Canti dell'Inferno
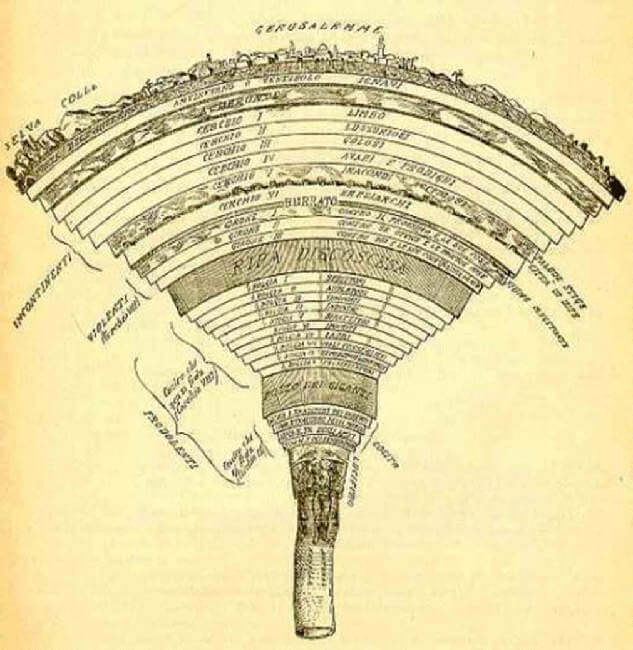 Sintsi dell'Inferno
Sintsi dell'Inferno
Canto I
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
3 ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa
dura esta selva selvaggia e aspra e forte
6 che nel pensier rinova la paura!
Tant'è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi
9 trovai, dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.
Io non so ben ridir com'i' v'entrai,
tant'era pien di sonno a quel punto
12 che la verace via abbandonai.
Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto,
là dove terminava quella valle
15 che m'avea di paura il cor compunto,
guardai in alto, e vidi le sue spalle
vestite già de' raggi del pianeta
18 che mena dritto altrui per ogne calle.
Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m'era durata
21 la notte ch'i' passai con tanta pieta.
E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
23 si volge a l'acqua perigliosa e guata,
così l'animo mio, ch'ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
27 che non lasciò già mai persona viva.
Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
30 sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso.
Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta,
una lonza leggiera e presta molto,
33 che di pel macolato era coverta;
e non mi si partia d'inanzi al volto,
anzi 'mpediva tanto il mio cammino,
36 ch'i' fui per ritornar più volte vòlto.
Temp'era dal principio del mattino,
e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle
39 ch'eran con lui quando l'amor divino
mosse di prima quelle cose belle;
sì ch'a bene sperar m'era cagione
42 di quella fiera a la gaetta pelle
l'ora del tempo e la dolce stagione;
ma non sì che paura non mi desse
45 la vista che m'apparve d'un leone.
Questi parea che contra me venisse
con la test'alta e con rabbiosa fame,
48 sì che parea che l'aere ne tremesse.
Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
51 e molte genti fé già viver grame,
questa mi porse tanto di gravezza
con la paura ch'uscia di sua vista,
54 ch'io perdei la speranza de l'altezza.
E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne 'l tempo che perder lo face,
57 che 'n tutti suoi pensier piange e s'attrista;
tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi 'ncontro, a poco a poco
60 mi ripigneva là dove 'l sol tace.
Mentre ch'i' rovinava in basso loco,
dinanzi a li occhi mi si fu offerto
63 chi per lungo silenzio parea fioco.
Quando vidi costui nel gran diserto,
"Miserere di me", gridai a lui,
66 "qual che tu sii, od ombra od omo certo!".
Rispuosemi: "Non omo, omo già fui,
e li parenti miei furon lombardi,
69 mantoani per patrïa ambedui.
Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,
e vissi a Roma sotto 'l buono Augusto
72 nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.
Poeta fui, e cantai di quel giusto
figliuol d'Anchise che venne di Troia,
75 poi che 'l superbo Ilïón fu combusto.
Ma tu perché ritorni a tanta noia?
perché non sali il dilettoso montech'
78 è principio e cagion di tutta gioia?".
"Or se' tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sì largo fiume?",
81 rispuos'io lui con vergognosa fronte.
"O de li altri poeti onore e lume,
vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore
84 che m'ha fatto cercar lo tuo volume.
Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore,
tu se' solo colui da cu' io tolsi
87 lo bello stilo che m'ha fatto onore.
Vedi la bestia per cu' io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,
90 ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi".
"A te convien tenere altro vïaggio",
rispuose, poi che lagrimar mi vide,
93 "se vuo' campar d'esto loco selvaggio;
ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,
96 ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide;
e ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,
99 e dopo 'l pasto ha più fame che pria.
Molti son li animali a cui s'ammoglia,
e più saranno ancora, infin che 'l veltro
102 verrà, che la farà morir con doglia.
Questi non ciberà terra né peltro,
ma sapïenza, amore e virtute,
105 e sua nazion sarà tra feltro e feltro.
Di quella umile Italia fia salute
per cui morì la vergine Cammilla,
108 Eurialo e Turno e Niso di ferute.
Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l'avrà rimessa ne lo 'nferno,
111 là onde 'nvidia prima dipartilla.
Ond'io per lo tuo me' penso e discerno
che tu mi segui, e io sarò tua guida,
114 e trarrotti di qui per loco etterno;
ove udirai le disperate strida,
vedrai li antichi spiriti dolenti,
117 ch'a la seconda morte ciascun grida;
e vederai color che son contenti
nel foco, perché speran di venire
120 quando che sia a le beate genti.
A le quai poi se tu vorrai salire,
anima fia a ciò più di me degna:
123 con lei ti lascerò nel mio partire;
ché quello imperador che là sù regna,
perch'i' fu' ribellante a la sua legge,
126 non vuol che 'n sua città per me si vegna.
In tutte parti impera e quivi regge;
quivi è la sua città e l'alto seggio:
129 oh felice colui cu' ivi elegge!".
E io a lui: "Poeta, io ti richeggio
per quello Dio che tu non conoscesti,
132 acciò ch'io fugga questo male e peggio,
che tu mi meni là dov'or dicesti,
sì ch'io veggia la porta di san Pietro
135 e color cui tu fai cotanto mesti".
Allor si mosse, e io li tenni dietro.
Letture di Dante a confronto
Lettore: Vittorio Sermonti
Canto I
Canto V
VI (parziale, dal v. 25)
Lettore: Carmelo Bene
Canto V
Canto VI
Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)
Lettore: Roberto Benigni
Lettore: Vittorio Gassman
Canto I
Canto III
Canto V
Canto XXVI
Canto III
"Per per si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno dolore,
3 per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina podestate,
6 la somma sapïenza e 'l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
9 Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate".
Queste parole di colore oscuro
vid'ïo scritte al sommo di una porta;
12 per ch'io: "Maestro, il senso lor m'è duro".
Ed elli a me, come persona accorta:
"Qui si convien lasciare ogne sospetto;
15 ogne viltà convien che qui sia morta.
Noi siam venuti al loco ov'i' t'ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
18 c'hanno perduto il ben de l'intelletto".
E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond'io mi confortai,
21 mi mise dentro a le segrete cose.
Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l'aere sanza stelle,
24 per ch'io al cominciar ne lagrimai.
Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d'ira,
27 voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevano un tumulto, il qual s'aggira
sempre in quell'aura sanza tempo tinta,
30 come la rena quando turbo spira.
E io ch'avea d'error la testa cinta,
dissi: "Maestro, che è quel ch'i' odo?
33 e che gent'è che par nel duol sì vinta?".
Ed elli a me: "Questo misero modo
tegnon l'anime triste di coloro
36 che visser sanza 'nfamia e sanza lodo.
Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
39 né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.
Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
42 ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli".
E io: "Maestro, che è tanto greve
a lor che lamentar li fa sì forte?".
45 Rispuose: "Dicerolti molto breve.
Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa,
48 che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte.
ama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
51 non ragioniam di lor, ma guarda e passa".
E io, che riguardai, vidi una 'nsegna
che girando correva tanto ratta,
54 che d'ogne posa mi parea indegna;
e dietro le venìa sì lunga tratta
di gente, ch'i' non averei creduto
57 che morte tanta n'avesse disfatta.
Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l'ombra di colui
60 che fece per viltade il gran rifiuto.
Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d'i cattivi,
63 a Dio spiacenti e a' nemici sui.
Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
erano ignudi e stimolati molto
66 da mosconi e da vespe ch'eran ivi.
Elle rigavan lor di sangue il volto,
che, mischiato di lagrime, a' lor piedi
69 da fastidiosi vermi era ricolto.
E poi ch'a riguardar oltre mi diedi,
vidi genti a la riva d'un gran fiume;
72 per ch'io dissi: "Maestro, or mi concedi
ch'i' sappia quali sono, e qual costume
le fa di trapassar parer sì pronte,
75 com'i' discerno per lo fioco lume".
Ed elli a me: "Le cose ti fier conte
quando noi fermerem li nostri passi
78 su la trista riviera d'Acheronte".
Allor con li occhi vergognosi e bassi,
temendo no 'l mio dir li fosse grave,
81 infino al fiume del parlar mi trassi.
Ed ecco verso noi venir per nave
un vecchio, bianco per antico pelo,
84 gridando: "Guai a voi, anime prave!
Non isperate mai veder lo cielo:
i' vegno per menarvi a l'altra riva
87 ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo.
E tu che se' costì, anima viva,
pàrtiti da cotesti che son morti".
90 Ma poi che vide ch'io non mi partiva,
disse: "Per altra via, per altri porti
verrai a piaggia, non qui, per passare:
93 più lieve legno convien che ti porti".
E 'l duca lui: "Caron, non ti crucciare:
vuolsi così colà dove si puote
96 ciò che si vuole, e più non dimandare".
Quinci fuor quete le lanose gote
al nocchier de la livida palude,
99 che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote.
Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude,
cangiar colore e dibattero i denti,
102 ratto che 'nteser le parole crude.
Bestemmiavano Dio e lor parenti,
l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme
105 di lor semenza e di lor nascimenti.
Poi si ritrasser tutte quante insieme,
forte piangendo, a la riva malvagia
108 ch'attende ciascun uom che Dio non teme.
Caron dimonio, con occhi di bragia
loro accennando, tutte le raccoglie;
111 batte col remo qualunque s'adagia.
Come d'autunno si levan le foglie
l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo
114 vede a la terra tutte le sue spoglie,
similemente il mal seme d'Adamo
gittansi di quel lito ad una ad una,
117 per cenni come augel per suo richiamo.
Così sen vanno su per l'onda bruna,
e avanti che sien di là discese,
120 anche di qua nuova schiera s'auna.
"Figliuol mio", disse 'l maestro cortese,
"quelli che muoion ne l'ira di Dio
123 tutti convegnon qui d'ogne paese;
e pronti sono a trapassar lo rio,
ché la divina giustizia li sprona,
126 sì che la tema si volve in disio.
Quinci non passa mai anima buona;
e però, se Caron di te si lagna,
129 ben puoi sapere omai che 'l suo dir suona".
Finito questo, la buia campagna
tremò si forte, che de lo spavento
132 la mente di sudore ancor mi bagna.
La terra lagrimosa diede vento,
che balenò una luce vermiglia
135 la qual mi vinse ciascun sentimento;
e caddi come l'uom cui sonno piglia.
Letture di Dante a confronto
Lettore: Vittorio Sermonti
Canto I
Canto V
VI (parziale, dal v. 25)
Lettore: Carmelo Bene
Canto V
Canto VI
Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)
Lettore: Roberto Benigni
Lettore: Vittorio Gassman
Canto I
Canto III
Canto V
Canto XXVI
Canto V
Così discesi del cerchio primaio
giù nel secondo, che men loco cinghia
3 e tanto più dolor, che punge a guaio.
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
essamina le colpe ne l'intrata;
6 giudica e manda secondo ch'avvinghia.
Dico che quando l'anima mal nata
li vien dinanzi, tutta si confessa;
9 e quel conoscitor de le peccata
vede qual loco d'inferno è da essa;
cignesi con la coda tante volte
12 quantunque gradi vuol che giù sia messa.
Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:
vanno a vicenda ciascuna al giudizio,
15 dicono e odono e poi son giù volte.
"O tu che vieni al doloroso ospizio",
disse Minòs a me quando mi vide,
18 lasciando l'atto di cotanto offizio,
"guarda com'entri e di cui tu ti fide;
non t'inganni l'ampiezza de l'intrare!".
21 E 'l duca mio a lui: "Perché pur gride?
Non impedir lo suo fatale andare:
vuolsi così colà dove si puote
24 ciò che si vuole, e più non dimandare".
Or incomincian le dolenti note
a farmisi sentire; or son venuto
27 là dove molto pianto mi percuote.
Io venni in loco d'ogne luce muto,
che mugghia come fa mar per tempesta,
30 se da contrari venti è combattuto.
La bufera infernal, che mai non resta,
mena li spirti con la sua rapina;
33 voltando e percotendo li molesta.
Quando giungon davanti a la ruina,
quivi le strida, il compianto, il lamento;
36 bestemmian quivi la virtù divina.
Intesi ch'a così fatto tormento
enno dannati i peccator carnali,
39 che la ragion sommettono al talento.
E come li stornei ne portan l'ali
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,
42 così quel fiato li spiriti mali
di qua, di là, di giù, di sù li mena;
nulla speranza li conforta mai,
45 non che di posa, ma di minor pena.
E come i gru van cantando lor lai,
faccendo in aere di sé lunga riga,
48 così vid'io venir, traendo guai,
ombre portate da la detta briga;
per ch'i' dissi: "Maestro, chi son quelle
51 genti che l'aura nera sì gastiga?".
"La prima di color di cui novelle
tu vuo' saper", mi disse quelli allotta,
54 "fu imperadrice di molte favelle.
A vizio di lussuria fu sì rotta,
che libito fé licito in sua legge,
57 per tòrre il biasmo in che era condotta.
Ell'è Semiramìs, di cui si legge
che succedette a Nino e fu sua sposa:
60 tenne la terra che 'l Soldan corregge
L'altra è colei che s'ancise amorosa,
e ruppe fede al cener di Sicheo;
63 poi è Cleopatràs lussurïosa.
Elena vedi, per cui tanto reo
tempo si volse, e vedi 'l grande Achille,
66 che con amore al fine combatteo.
Vedi Parìs, Tristano"; e più di mille
ombre mostrommi e nominommi a dito,
69 ch'amor di nostra vita dipartille.
Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito
nomar le donne antiche e ' cavalieri,
72 pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.
I' cominciai: "Poeta, volontieri
parlerei a quei due che 'nsieme vanno,
75 e paion sì al vento esser leggeri".
Ed elli a me: "Vedrai quando saranno
più presso a noi; e tu allor li priega
78 per quello amor che i mena, ed ei verranno".
Sì tosto come il vento a noi li piega,
mossi la voce: "O anime affannate,
81 venite a noi parlar, s'altri nol niega!".
Quali colombe dal disio chiamate
con l'ali alzate e ferme al dolce nido
84 vegnon per l'aere dal voler portate;
cotali uscir de la schiera ov'è Dido,
a noi venendo per l'aere maligno,
87 sì forte fu l'affettüoso grido.
"O animal grazïoso e benigno
che visitando vai per l'aere perso
90 noi che tignemmo il mondo di sanguigno,
se fosse amico il re de l'universo,
noi pregheremmo lui de la tua pace,
93 poi c'hai pietà del nostro mal perverso.
Di quel che udire e che parlar vi piace,
noi udiremo e parleremo a voi,
96 mentre che 'l vento, come fa, ci tace.
Siede la terra dove nata fui
su la marina dove 'l Po discende
99 per aver pace co' seguaci sui.
Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,
prese costui de la bella persona
102 che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.
Amor, ch'a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
105 che, come vedi, ancor non m'abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense".
108 Queste parole da lor ci fuor porte.
Quand'io intesi quell'anime offense,
china' il viso e tanto il tenni basso,
111 fin che 'l poeta mi disse: "Che pense?".
Quando rispuosi, cominciai: "Oh lasso,
quanti dolci pensier, quanto disio
114 menò costoro al doloroso passo!".
Poi mi rivolsi a loro e parla' io,
e cominciai: "Francesca, i tuoi martìri
117 a lagrimar mi fanno tristo e pio.
Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri,
a che e come concedette amore
120 che conosceste i dubbiosi disiri?".
E quella a me: "Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
123 ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore.
Ma s'a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
126 dirò come colui che piange e dice.
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
129 soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
132 ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
135 questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse:
138 quel giorno più non vi leggemmo avante".
Mentre che l'uno spirto questo disse,
l'altro piangëa; sì che di pietade
141 io venni men così com'io morisse.
E caddi come corpo morto cade.
Letture di Dante a confronto
Lettore: Vittorio Sermonti
Canto I
Canto V
VI (parziale, dal v. 25)
Lettore: Carmelo Bene
Canto V
Canto VI
Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)
Lettore: Roberto Benigni
Lettore: Vittorio Gassman
Canto I
Canto III
Canto V
Canto XXVI
Canto VI
Al tornar de la mente, che si chiuse
dinanzi a la pietà d'i due cognati,
3 che di trestizia tutto mi confuse,
novi tormenti e novi tormentati
mi veggio intorno, come ch'io mi mova
6
e ch'io mi volga, e come che io guati.
Io sono al terzo cerchio, de la piova
etterna, maladetta, fredda e greve;
9
regola e qualità mai non l'è nova.
Grandine grossa, acqua tinta e neve
per l'aere tenebroso si riversa;
12
pute la terra che questo riceve.
Cerbero, fiera crudele e diversa,
con tre gole caninamente latra
15
sovra la gente che quivi è sommersa.
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,
e 'l ventre largo, e unghiate le mani;
18
graffia li spirti ed iscoia ed isquatra.
Urlar li fa la pioggia come cani;
de l'un de' lati fanno a l'altro schermo;
21
volgonsi spesso i miseri profani.
Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,
le bocche aperse e mostrocci le sanne;
24
non avea membro che tenesse fermo.
E 'l duca mio distese le sue spanne,
prese la terra, e con piene le pugna
27
la gittò dentro a le bramose canne.
Qual è quel cane ch'abbaiando agogna,
e si racqueta poi che 'l pasto morde,
30
ché solo a divorarlo intende e pugna,
cotai si fecer quelle facce lorde
de lo demonio Cerbero, che 'ntrona
33
l'anime sì, ch'esser vorrebber sorde.
Noi passavam su per l'ombre che adona
la greve pioggia, e ponavam le piante
36
sovra lor vanità che par persona.
Elle giacean per terra tutte quante,
fuor d'una ch'a seder si levò, ratto
39
ch'ella ci vide passarsi davante.
"O tu che se' per questo 'nferno tratto",
mi disse, "riconoscimi, se sai:
42
tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto".
E io a lui: "L'angoscia che tu hai
forse ti tira fuor de la mia mente,
45
sì che non par ch'i' ti vedessi mai.
Ma dimmi chi tu se' che 'n sì dolente
loco se' messo, e hai sì fatta pena,
48
che, s'altra è maggio, nulla è sì spiacente".
Ed elli a me: "La tua città, ch'è piena
d'invidia sì che già trabocca il sacco,
51
seco mi tenne in la vita serena.
Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:
per la dannosa colpa de la gola,
54
come tu vedi, a la pioggia mi fiacco.
E io anima trista non son sola,
ché tutte queste a simil pena stanno
57
per simil colpa". E più non fé parola.
Io li rispuosi: "Ciacco, il tuo affanno
mi pesa sì, ch'a lagrimar mi 'nvita;
60
ma dimmi, se tu sai, a che verranno
li cittadin de la città partita;
s'alcun v'è giusto; e dimmi la cagione
63
per che l'ha tanta discordia assalita".
E quelli a me: "Dopo lunga tencione
verranno al sangue, e la parte selvaggia
66
caccerà l'altra con molta offensione.
Poi appresso convien che questa caggia
infra tre soli, e che l'altra sormonti
69
con la forza di tal che testé piaggia.
Alte terrà lungo tempo le fronti,
tenendo l'altra sotto gravi pesi,
72
come che di ciò pianga o che n'aonti.
Giusti son due, e non vi sono intesi;
superbia, invidia e avarizia sono
75
le tre faville c'hanno i cuori accesi".
Qui puose fine al lagrimabil suono.
E io a lui: "Ancor vo' che mi 'nsegni,
78
e che di più parlar mi facci dono.
Farinata e 'l Tegghiaio, che fuor sì degni,
Iacopo Rusticucci, Arrigo e 'l Mosca
81
e li altri ch'a ben far puoser li 'ngegni,
dimmi ove sono e fa ch'io li conosca;
ché gran disio mi stringe di savere
84
se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca".
E quelli: "Ei son tra l'anime più nere;
diverse colpe giù li grava al fondo:
87
se tanto scendi, là i potrai vedere.
Ma quando tu sarai nel dolce mondo,
priegoti ch'a la mente altrui mi rechi:
90
più non ti dico e più non ti rispondo".
Li diritti occhi torse allora in biechi;
guardommi un poco e poi chinò la testa:
93
cadde con essa a par de li altri ciechi.
E 'l duca disse a me: "Più non si desta
di qua dal suon de l'angelica tromba,
96
quando verrà la nimica podesta:
ciascun rivederà la trista tomba,
ripiglierà sua carne e sua figura,
99
udirà quel ch'in etterno rimbomba".
Sì trapassammo per sozza mistura
de l'ombre e de la pioggia, a passi lenti,
102
toccando un poco la vita futura;
per ch'io dissi: "Maestro, esti tormenti
crescerann'ei dopo la gran sentenza,
105
o fier minori, o saran sì cocenti?".
Ed elli a me: "Ritorna a tua scïenza,
che vuol, quanto la cosa è più perfetta,
108
più senta il bene, e così la doglienza.
Tutto che questa gente maladetta
in vera perfezion già mai non vada,
11
di là più che di qua essere aspetta".
Noi aggirammo a tondo quella strada,
parlando più assai ch'i' non ridico;
114
venimmo al punto dove si digrada:
quivi trovammo Pluto, il gran nemico.
Letture di Dante a confronto
Lettore: Vittorio Sermonti
Canto I
Canto V
VI (parziale, dal v. 25)
Lettore: Carmelo Bene
Canto V
Canto VI
Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)
Lettore: Roberto Benigni
Lettore: Vittorio Gassman
Canto I
Canto III
Canto V
Canto XXVI
Canto XXVI
Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande,
che per mare e per terra batti l'ali,
3
e per lo 'nferno tuo nome si spande!
Tra li ladron trovai cinque cotali
tuoi cittadini onde mi ven vergogna,
6
e tu in grande orranza non ne sali.
Ma se presso al mattin del ver si sogna,
tu sentirai, di qua da picciol tempo,
9
di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna.
E se già fosse, non saria per tempo.
Così foss'ei, da che pur esser dee!
12
ché più mi graverà, com' più m'attempo.
Noi ci partimmo, e su per le scalee
che n'avean fatto iborni a scender pria,
1
rimontò 'l duca mio e trasse mee;
e proseguendo la solinga via,
tra le schegge e tra ' rocchi de lo scoglio
18
lo piè sanza la man non si spedia.
Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio
quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi,
21
e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio,
perché non corra che virtù nol guidi;
sì che, se stella bona o miglior cosa
24
m'ha dato 'l ben, ch'io stesso nol m'invidi.
Quante 'l villan ch'al poggio si riposa,
nel tempo che colui che 'l mondo schiara
27
la faccia sua a noi tien meno ascosa,
come la mosca cede a la zanzara,
vede lucciole giù per la vallea,
30
forse colà dov'e' vendemmia e ara:
di tante fiamme tutta risplendea
l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi
33
tosto che fui là 've 'l fondo parea.
E qual colui che si vengiò con li orsi
vide 'l carro d'Elia al dipartire,
36
quando i cavalli al cielo erti levorsi,
che nol potea sì con li occhi seguire,
ch'el vedesse altro che la fiamma sola,
39
sì come nuvoletta, in sù salire:
tal si move ciascuna per la gola
del fosso, ché nessuna mostra 'l furto,
42
e ogne fiamma un peccatore invola.
Io stava sovra 'l ponte a veder surto,
sì che s'io non avessi un ronchion preso,
45
caduto sarei giù sanz'esser urto.
E 'l duca, che mi vide tanto atteso,
disse: "Dentro dai fuochi son li spirti;
48
catun si fascia di quel ch'elli è inceso".
"Maestro mio", rispuos'io, "per udirti
son io più certo; ma già m'era avviso
51
che così fosse, e già voleva dirti:
chi è 'n quel foco che vien sì diviso
di sopra, che par surger de la pira
54
dov'Eteòcle col fratel fu miso?".
Rispuose a me: "Là dentro si martira
Ulisse e Dïomede, e così insieme
57
a la vendetta vanno come a l'ira;
e dentro da la lor fiamma si geme
l'agguato del caval che fé la porta
60
onde uscì de' Romani il gentil seme.
Piangevisi entro l'arte per che, morta,
Deïdamìa ancor si duol d'Achille,
63
e del Palladio pena vi si porta".
"S'ei posson dentro da quelle faville
parlar", diss'io, "maestro, assai ten priego
66
e ripriego, che 'l priego vaglia mille,
che non mi facci de l'attender niego
fin che la fiamma cornuta qua vegna;
69
vedi che del disio ver' lei mi piego!".
Ed elli a me: "La tua preghiera è degna
di molta loda, e io però l'accetto;
72
ma fa che la tua lingua si sostegna.
Lascia parlare a me, ch'i' ho concetto
ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi,
75
perch'e' fuor greci, forse del tuo detto".
Poi che la fiamma fu venuta quivi
dove parve al mio duca tempo e loco,
78
in questa forma lui parlare audivi:
"O voi che siete due dentro ad un foco,
s'io meritai di voi mentre ch'io vissi,
81
s'io meritai di voi assai o poco
quando nel mondo li alti versi scrissi,
non vi movete; ma l'un di voi dica
84
dove, per lui, perduto a morir gissi".
Lo maggior corno de la fiamma antica
cominciò a crollarsi mormorando,
87
pur come quella cui vento affatica;
indi la cima qua e là menando,
come fosse la lingua che parlasse,
90
gittò voce di fuori, e disse: "Quando
mi diparti' da Circe, che sottrasse
me più d'un anno là presso a Gaeta,
93
prima che sì Enëa la nomasse,
né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né 'l debito amore
96
lo qual dovea Penelopè far lieta,
vincer potero dentro a me l'ardore
ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto
99
e de li vizi umani e del valore;
ma misi me per l'alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
102
picciola da la qual non fui diserto.
L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna,
fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi,
105
e l'altre che quel mare intorno bagna.
Io e ' compagni eravam vecchi e tardi
quando venimmo a quella foce stretta
108
dov'Ercule segnò li suoi riguardi
acciò che l'uom più oltre non si metta;
da la man destra mi lasciai Sibilia,
111
da l'altra già m'avea lasciata Setta.
"O frati", dissi, "che per cento milia
perigli siete giunti a l'occidente,
114
a questa tanto picciola vigilia
d'i nostri sensi ch'è del rimanente
non vogliate negar l'esperïenza,
117
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
120
ma per seguir virtute e canoscenza".
Li miei compagni fec'io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,
123
che a pena poscia li avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel mattino,
de' remi facemmo ali al folle volo,
126
sempre acquistando dal lato mancino.
Tutte le stelle già de l'altro polo
vedea la notte, e 'l nostro tanto basso,
129
che non surgëa fuor del marin suolo.
Cinque volte racceso e tante casso
lo lume era di sotto da la luna,
132
poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo,
quando n'apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
135
quanto veduta non avëa alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;
ché de la nova terra un turbo nacque
138
e percosse del legno il primo canto.
Tre volte il fé girar con tutte l'acque;
a la quarta levar la poppa in suso
141
e la prora ire in giù, com'altrui piacque,
infin che 'l mar fu sovra noi richiuso".
Letture di Dante a confronto
Lettore: Vittorio Sermonti
Canto I
Canto V
VI (parziale, dal v. 25)
Lettore: Carmelo Bene
Canto V
Canto VI
Canto XXVI (parziale, vv. 76-142)
Lettore: Roberto Benigni
Lettore: Vittorio Gassman
Canto I
Canto III
Canto V
Canto XXVI
Inferno
Indice
- Inferno
- In quali culture
- Culti mediorientali
- Egiziani
- Greci e Romani
- Ebraismo
- Cristianesimo
- Nella teologia cristiana
- L'inferno secondo J. Milton
- Congresso ADI
- A. Rimbaud: Una stagione all'inferno
- Bibliografia
- Violenza sulle donne
- Il genocidio in Rwanda
- Bush racconta l'11 settembre
Inferno è il termine con il quale in ambito religioso, si indica il luogo metafisico (o fisico) che attende, dopo la morte, le anime (o i corpi) degli uomini che hanno rifiutato Dio scegliendo in vita il male ed il peccato. Più propriamente, il termine "Inferno" deriva dal latino "infernus", cioè "posto in basso", "inferiore" ed è quindi sinonimo di "inferus"; tuttavia, la parola "inferno" è da riferirsi solo al concetto delle tre grandi religioni monoteistiche, mentre la parola "inferi" si può, più ampiamente, riferire a tutte le altre culture antiche e moderne. Secondo quasi tutte le culture, l'Inferno è caratterizzato da estremo dolore, enorme disperazione e tormento eterno. Può essere visto come un luogo metafisico o spirituale che ospita le anime incorporee dei morti, oppure come luogo fisico sede di tormenti altrettanto fisici. Questa visione è più frequente andando a ritroso nelle epoche, mentre ai giorni nostri il concetto di Inferno si spiritualizza e riguarda prevalentemente il tormento dell'anima. L'Inferno costituisce una condizione di dannazione eterna e questa condizione è solitamente assegnata in base alla condotta morale e spirituale che la persona ha tenuto in vita.
In quali culture è presente
È un concetto presente in un gran numero di culture precristiane, cristiane e non cristiane. È solitamente identificato con un mondo oscuro e sotterraneo, collegato all'operato del Dio e della creatura superiore che ha originariamente introdotto nella Creazione l'errore, la menzogna, il peccato e, in definitiva, il principio distruttivo dell'ordine delle cose; tale creatura superiore si identifica nel diavolo, nella divinità del male o nell'ebraico/cristiano Satana, a seconda delle culture. In tal senso il concetto di tentatore o demonio, di Inferno e il concetto stesso di male sono intrinsecamente legati. Il tentatore, o divinità negativa, solitamente genera, con il suo operato, tanto l'Inferno, quanto le condizioni che vi trascinano i viventi abbruttendo le loro scelte morali.
Con il passare dei secoli si nota via via una più netta distinzione tra principio divino positivo, costruttivo e misericordioso, e il principio demoniaco, negativo, distruttivo e, quasi sempre, ingannatore. Questa impostazione è fondamentale nelle religioni monoteiste di derivazione Accadico-Semitica (Ebraismo, Cristianesimo e Islam) che sono oggi le più diffuse e professate. Nelle religioni delle origini mediorientali (Babilonesi, Accadici, Semiti, Greci e Fenici) il Chaos, demonio o principe degli inferi, è l'unico vivente prima della nascita degli dei, che dal caos si originano e si coalizzano per contenerlo nei limiti dell'ordine (cosmos).
Culti mediorientali
Accadici, Semitici, Caldei
Le religioni monoteiste, che oggi sono le più professate al mondo, affondano le loro radici negli antichi culti Accadici, Semitici, Caldei e Assiro-Babilonesi. La cosmogonia e la cosmologia delle tre grandi religioni deriva, molto probabilmente, dalla regione e dalla popolazione delle Caldea e da lì i Babilonesi la passarono agli Ebrei. I reperti oggi decifrati risalgono a circa 3.000 anni fa e raccontano la nascita del mondo, delle cose, degli dei e della lotta tra bene e male in modo estremamente vicino a quello che è familiare a chi professa l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam.
Nello Zoroastrismo, dove è assai più netta la contrapposizione tra Dio del Bene e Dio del male, l'anima del defunto deve passare sopra il cinvato pertush, il ponte di colui che dà il rendiconto, che si stende tra il picco del Giudizio e il sacro monte Alborz, e su questo ponte sarà deciso il suo destino: esso, infatti, si stende sull'abisso degli inferi e si allarga distendendosi ampio quanto nve giavellotti per i buoni, ma si riduce alla lama come di un rasoio per i malvagi che, caduti nell'abisso, si ritrovano condannati all'Inferno nelle mani di Ahriman, il malefico dio mentitore. In tutti questi casi l'Inferno è un luogo sotterraneo, buio, abitato da creature mostruose, sorde ad ogni ragionevolezza e ad ogni bene umanamente concepibile.
Egiziani
Nei culti egizi antichi l'Inferno è Amenti, ha una valenza duplice e duplice è il ruolo del dio malvagio Seth, da un lato è il luogo di soggiorno delle anime vuote, malvagi, dall'altro è la sede di creature primordiali e mostruose, prima fra tutte Apep, serpente gigantesco che attacca Ra, per spegnere il Sole e impedire che sorga al mattino. Il ruolo della divinità malefica e distruttrice del male è condiviso da figure molto diverse tra loro. Alle creature caotiche e mostruose di Amenti, il mondo sotterraneo, si contrappone Seth: il dio "del sole che prosciuga", della sete febbrile che uccide, del tramonto del giorno e della distruzione delle cose.
Seth è il Signore del deserto, adorato dai carovanieri che si spostavano tra un'oasi e l'altra. Seth è una divinità a tutti gli effetti, di pari potere agli altri dei e che merita adorazione per la sua possanza. Assolve, inoltre, anche compiti fondamentali: è il dio della guerra e della forza bruta, che insegna ad asservire nella lotta violenta per vincere in battaglia e trovare l'onore.
Alla morte, la persona passa l'orizzonte occidentale e scende, attraverso Atmu, nell'Amenti, il mondo sotterraneo. La salvezza della sua anima dipende dalla preservazione del suo "doppio" o "altro è", che risiede nella mummia o in una statua del suo corpo. Per frustrare i tentativi di distruzione e di consunzione di Seth e della sua corte, vengono recitate formule magiche propiziatorie per ingraziarsi il Dio oscuro e vengono inseriti nella tomba cibi e bevande.
Tuttavia l'anima per salvarsi deve anche aver condotto una vita giusta e devota. Il suo cuore viene pesato nella Sala della Verità per vedere se sia pesante o leggero, mentre il morto dichiara alle divinità: "Non commisi del male, non commisi violenza, non tormentai alcun cuore, non rubai, né feci che qualcuno fosse ucciso col tradimento. Non ridussi i sacrifici, non ferii, non dichiarai il falso né feci piangere alcuno, non mi masturbai né fornicai. Non peccai, o commisi perfidie, non danneggiai la terra coltivata, non fui l'accusatore di alcuno, non mi infuriai senza una buona ragione, non fui sordo alla parola della verità. Non compii stregonerie, né fui blasfemo, non feci che il servo fosse maltrattato dal suo padrone, né rifiutai con odio Dio dal mio cuore".
Il cuore è posto sul piatto di una bilancia, e, nel caso sia più pesante della piuma che è posta sull'altro piatto, sarà dato in pasto ad Ammit, (la divoratrice) creatura mostruosa di Amenti, oppure sarà reincarnato in un maiale e rispedito nel suo mondo. Tale rituale mistico è detto "psicostasia", cioè "pesatura dell'anima". Tuttavia anche nell'inferno Seth ha una valenza duplice rispetto al concetto di bene e male, perché se da un lato è il Dio della distruzione e della consunzione del duplice della persona morta, dall'altro è uno degli dei che protegge la barca di Ra che, nottetempo, transita negli inferi per risorgere nuovamente il mattino dopo. Ra viene attaccato da Apep, il serpente gigantesco e mostruoso e Seth lo difende, gettando al collo del mostro una catena di ferro, che gli fa rigettare ciò che ha inghiottito nella sua fame mostruosa. Le rare volte in cui non vince, si ha un'eclissi di Sole. Con il passare del tempo il culto di Seth diminuisce, ed egli diviene una divinità minore, realmente crudele e malvagia, che slitterà poi, con la tradizione cristiana, nella figura di Satana.
Greci e Romani
Nella civiltà greca, ed in seguito in quella romana, non compare tanto il termine "Inferno", quanto il termine "Inferi", per indicare il sotterraneo "regno dei morti", il cui re è il dio Ade (Plutone o Dite per i Romani) e la cui regina è Persefone (Proserpina per i Romani).
Ade come denominazione di "regno degli Inferi", in realtà, è solo una trasposizione che identifica tale regno col suo stesso
re e signore.
Il regno dei morti greco/latino era, al contrario di quello ebraico e cristiano, un vero e proprio luogo fisico, al quale si
poteva persino accedere in terra da alcuni luoghi impervi, difficilmente raggiungibili o comunque segreti e inaccessibili ai
mortali; nella tradizione greca, per esempio, uno degli ingressi all'Ade si trovava nel paese dei Cimmeri, che si trovava al
confine crepuscolare dell'Oceano, e proprio in questa regione remota Odisseo dovette recarsi per discendere all'Ade ed
incontrare l'ombra dell'indovino Tiresia;
nella tradizione romana, invece, uno degli ingressi infernali si trovava vicino al lago dell'Averno, che poi divenne il nome
del regno infernale stesso, dal quale Enea discese insieme alla Sibilla cumana.
Per quanto riguarda la geografia e la topografia degli Inferi, Omero (nell'"Odissea") non gli dà un carattere di vero e proprio
"regno" esteso, ma lo descrive solamente come una sfera fisica oscura e misteriosa, perlopiù preclusa ai viventi, dove
soggiornano in eterno le ombre (e non le anime) di tutti gli uomini, senza apparente distinzione tra ombre buone ed ombre
malvagie e senza nemmeno un'assegnazione di pena o di premio in base ai meriti terreni.
Solo in seguito si formò il concetto dei "Campi Elisi", ovvero il luminoso luogo ove soggiornano in eterno le anime pie e
virtuose, senza gioia né tristezza, e il concetto del "Tartaro", cioè il tenebroso e terribile luogo dove in eterno vengono
punite le anime dei malvagi.
Con Virgilio, poi, che nell' "Eneide" narra la discesa di Enea agli Inferi, la topografia infernale raggiunge la sua massima espressione, nonché estensione: anche il poeta latino divide gli Inferi tra Tartaro e Campi Elisi, ma aggiunge il "Vestibolo", l'atrio infero popolato da mostri e demoni vari, e, recuperando la tradizione greco-latina, nomina i fiumi infernali, cioè Stige, Acheronte, Flegetonte, Lete e Cocito. Inoltre, è sua invenzione poetica la " città di Dite", ovvero la città del re degli Inferi (Dite, appunto) che verrà ripresa nella "Divina Commedia" da Dante Alighieri come la città del re dell'Inferno, cioè Lucifero. Le pene del Tartaro o il premio dei Campi Elisi non erano decisi dagli dei, bensì dai tre giudici infernali Minosse, Radamanto (fratello di Minosse) ed Eaco, che, in base alla condotta morale tenuta in vita dell'ombra, le assegnavano la propria dimora eterna. Per raggiungere il luogo dove i giudici emettevano il verdetto bisognava entrare dall'ingresso guardato da Cerbero poi raggiungere il fiume Acheronte e pagare Caronte per essere traghettati dall'altra parte.
Ebraismo
Nell'Ebraismo antico l'Inferno comincia a cambiare considerevolmente connotazione, rispetto alle altre culture e continua il suo processo di spiritualizzazione. Satana, l'essere superiore attore del male, si configura non più come un dio, ma come una creatura che proviene da Dio stesso e, in una certa accezione, è un suo servitore. Satana dovrebbe annunciare l'"Ira di Dio" e la sua vendetta ai peccatori, ma si diverte crudelmente a tormentarli per il puro gusto della malvagità dell'atto e delle sofferenze indicibili che questo causa.
In quest'ottica tanto l'Inferno quanto il demonio stesso, acquisiscono i nomi ed alcuni tratti caratteristici dei culti dei popoli nemici vicini, i peccatori per eccellenza e traditori della chiamata del Dio di Abramo, che si macchiano dei peggiori crimini. Così il demonio assume anche il nome di Belzebù, una divinità Fenicia, e Hinnom (cioè la Gehenna) diviene il nome dell'Inferno al posto di Sheol, il "posto dei morti sottoterra". Hinnom era il nome del posto dove veniva adorato Moloch, il cui idolo era di bronzo e ospitava una fornace ardente dove venivano gettate le vittime, solitamente giovani, dei sacrifici umani. L'Inferno passa dunque da semplice luogo "sotterraneo" a fornace ardente dove i malvagi soffrono bruciando, a causa della presenza corruttrice di una creatura tentatrice, inconcepibilmente e gratuitamente malvagia: un'immagine che ritroviamo successivamente nel culto cristiani.
Cristianesimo
La parola latina "inferno" non assume nelle scritture greche del Nuovo Testamento il significato di tormento di fuoco o luogo abitato dalle fiamme. Il termine latino "inferno" nelle bibbie italiane non si traduce in maniera sempre uniforme e il termine greco "ades" mantiene il significato che troviamo nell'Antico Testamento cioè luogo di inattività. Gli ebrei non concepivano l'uomo dotato di un'anima immortale pertanto sembra che il significato attuale dato all'inferno biblico derivi da tradizioni teologiche più tardive e risenta dell'influenza della Divina Commedia di Dante.
Nella teologia cristiana
La dottrina cristiana sul tema infernale riprende quella ebraica e più in genere le figure tipiche delle religioni del Mediterraneo. L'Inferno è un luogo dominato dalle fiamme e dalle tenebre, da cui i dannati possono vedere i santi, i beati e i penitenti che riposano nella beatitudine del Paradiso o nell’attesa del Purgatorio, e non possono ottenere sollievo alcuno, privi d'ogni speranza.
Va comunque precisato che il termine "inferno" non è mai citato nella Bibbia.
Per i teologi della filosofia Scolastica, l'Inferno è semplicemente la lontananza da Dio, la privazione della Sua luce divina, e proprio in questo consiste in realtà la pena infernale, al di là dell'immaginario poetico. Infatti, l'anima ha naturale e ardente desiderio di Dio, cioè dell'Infinito, della Verità, della Bellezza e dell'Amore Assoluto; dunque, la privazione "in eternuum" di tale supremo obiettivo del desiderio umano, condanna l'anima alla propria perenne sofferenza. La vicinanza, essere in Dio, da Dio e per Dio, è per l'anima, sul piano oggettivo, la realizzazione della propria essenza originaria, e, su quello soggettivo, la propria felicità; in realtà, questi due "piani", in Dio si sovrappongono, diventando un unico, sommo "piano". Non è Dio a dannare l'anima, dunque, ma è l'anima che si condanna durante la vita, rifiutando stoltamente la Via della salvezza.
L'Inferno secondo John Milton
L'Inferno è stato descritto e mostrato anche nell'opera del poeta inglese John Milton "Paradiso Perduto" ("Paradise Lost", 1667).
Egli narra la caduta di Satana/Lucifero, dalla cui stessa iniquità nacque l'Inferno, per volontà divina: Dio stesso, dunque, dispose la creazione di un luogo di eterna e totale oscurità e sofferenza, nel quale poter esiliare gli angeli ribelli, che per Sua volontà non annichilì. La descrizione che Milton dà dell'Inferno è una delle più spaventevoli ed impressionanti della letteratura e dell'immaginario poetico:
« (...) egli subito osserva quell'aspro e pauroso e desolato luogo,
quella prigione orribile e attorno fiammeggiante,
come una grande fornace, e tuttavia da quelle
fiamme nessuna luce, ma un buio trasparente, una tenebra
nella quale si scorgono visioni di sventura,
regioni di dolore e ombre d'angoscia, e il riposo e la pace
non si troveranno, né mai quella speranza che ogni cosa
solitamente penetra; e solo una tortura senza fine
urge perenne, e un diluvio di fiamme nutrito
di zolfo sempre ardente, mai consunto (...) »
(John Milton, "Paradiso Perduto", libro I, vv. 59-69)
Milton, tuttavia, ispirato dal poema di Dante e influenzato dalla teologia cristiana, non dà una semplice visione poetica e metafisica dell'Inferno, ma anch'esso dichiara la dimensione infernale anche come una dimensione spirituale nell'uomo. Infatti, il "suo" stesso Satana, dice:
«Me miserevole! Per quale varco potrò mai fuggire
l'ira infinita e l'infinita disperazione?
Perché dovunque fugga è sempre l'inferno; sono io l'inferno (...) »
(John Milton, "Paradiso Perduto", libro IV, vv. 76-78)
Dunque, l'Inferno di Milton è nell'anima, prima che nella sfera metafisica, anzi, la sfera metafisica stessa è nell'anima.
CONGRESSO ADI – SD Torino 2011
Dante e Levi: Percorsi di Letture Parallele
di L. Mondo
La redazione definitiva di Se questo è un uomo del 1958 si apre con una poesia senza titolo posta in epigrafe che ricalca
alcuni versetti di Shemà ( che in ebraico significa “Ascolta”), la preghiera fondamentale degli ebrei. Nel decimo verso
compare la prima parola tratta dalla Commedia, si tratta del verbo “considerate”:
Considerate se questo è un uomo/ che lavora nel fango (…) considerate se questa è una donna/, senza capelli e senza nome
,
il riferimento è alla dignità calpestata degli esseri umani e la memoria corre subito all’invocazione di Ulisse ai suoi
compagni nella bolgia dei consiglieri di frode, Canto XXVI dell’Inferno, vv.118-120:
Considerate la vostra semenza :/ fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguire virtute e conoscenza
.
La meditazione su ciò che distingue l’uomo dal bruto e sul compito morale della conoscenza accomuna già in apertura i due autori.
La figura dell’eroe greco sarà poi al centro del capitolo Il canto di Ulisse dove il Levi prigioniero prova a raccontare al
giovane deportato Jean, che nel campo svolge la funzione di Pikolo ( Piccolo), vale a dire fattorino-scritturale, addetto
alla pulizia della baracca, qualcosa dell’Italia.
E’ uno dei rari momenti di tregua nei quali la comunicazione umana è ancora possibile.
Come scrive Giovanni Tesio nell’Introduzione a Se questo è un uomo ( Einaudi, Torino 1992), per Levi il vero incontro con
Dante avviene nel lager, attraverso quella esperienza Dante diventa lo scrittore guida e, dopo il lager Dante sarà l’ispiratore
del viaggio a ritroso per riportare alla luce, attraverso la scrittura, la memoria dell’inferno vissuto.
Come l’Inferno di Dante, il libro di Levi contiene un Prologo, che si colloca fuori dall’Inferno ( il primo capitolo intitolato Il viaggio) da questo momento in poi l’autore utilizzerà soltanto il tempo presente, non un presente storico ma un presente assoluto, poiché l’idea del tempo dentro il lager non contempla più la nozione di futuro e rimuove l’esistenza del passato. La scelta del presente serve anche a ricordare che, come l’inferno dantesco, anche Auschwitz è sempre presente, in quanto eterno pericolo che incombe sull’umanità Nel viaggio possiamo seguire il passaggio dal mondo dell’umanità a quello della disumanità, un viaggio dentro un vagone merci, “verso il nulla, un viaggio all’ingiù, verso il fondo”( Se questo è un uomo, op.cit, p. 10) dove subito si presenta alla memoria l’imbuto dell’inferno dantesco.
In Levi, come in Dante, scrive Cesare Segre “Il modo per indicare il raggiungimento dell’umiliazione massima è topologicamente uno sprofondamento “siamo arrivati al fondo”, mentre la soglia del passaggio alla tragedia avviene attraverso l’irruzione del grottesco: l’apparizione degli strani individui che si muovono come pupazzi con in testa un buffo berrettino e una palandrana a righe e che marciano al ritmo della canzone Rosamunda. ( C. Segre, Letteratura italiana. Il secondo Novecento, Einaudi, Torino 1996- 2007, p. 144)
Forti sono le assonanze tra la condizione dei prigionieri e quella dei dannati: dai barbarici latrati dei tedeschi, al soldato,
moderno Caronte, che anziché apostrofare i deportati gridando “Guai a voi anime prave”, come Levi si aspetta di sentire,
memore del canto III dell’Inferno, domanda orologi e denaro.
Infine la citazione dantesca si fa esplicita all’inizio del secondo capitolo intitolato Sul fondo, ma con una distinzione
degradante. Se questo è l’inferno, dirà Levi, si tratta di un inferno moderno, dove non c’è posto per la sacralità,
la solennità. Il Caronte-soldato tedesco è un personaggio squallido e mediocre che non ha nessuno dei tratti apocalittici
dei personaggi luciferini danteschi. In questi soldati c’è solo la convinzione di dovere ubbidire a un ordine di servizio,
è “la banalità del male” così come ce l’ha descritta nel suo saggio Hannah Arendt, cioè il male perpetrato con
l’abito dimesso e quotidiano del conformismo.
Il capitolo Sul fondo comincia con l’immagine di una scritta ARBEIT MACHT FREI ( Il lavoro rende liberi): beffardo ammonimento
che ricalca le parole scolpite sulla porta dell’Inferno dantesco, “Il cui ricordo ancora mi percuote nei sogni”
dice Levi (op.cit, p. 17); “percuote” è verbo caro a Dante
(or son venuto/ là dove molto pianto mi percuote,
Inferno, canto V, vv. 26-27;
tosto che nella vista mi percosse
Purgatorio, canto XXX, v.40,).
Attraverso questa porta si entra nella città dolente, nell’eterno dolore, tra la perduta gente di Auschwitz-Birkenau.
Levi è lo scrittore che forse più di altri sopravvissuti alla Shoah ha posto il linguaggio al centro dei suoi resoconti del Lager, Levi forza il linguaggio verso la chiarezza lapidaria, la precisione del semplice dettaglio, la concisione descrittiva, il ritorno alla lingua ordinaria; interroga la lingua e il lettore su una nuova riflessione, sul significato dei termini usuali di “bene” e “male”, “giusto” e “ingiusto”, “fame, paura, dolore”, ecc.
Affermare che alcuni aspetti del lager sono inesprimibili e arrestarsi davanti all’indicibile, mantenendo il diritto etico all’esistenza di una soglia di riservatezza, diviene in Levi un topos retorico, una strategia della comunicazione che produce una reazione forte e raggiunge lo scopo di dire, pur negando di dire.
Mai in Levi prevale la resa al silenzio, egli stesso ne I sommersi e i salvati distingue i sopravvissuti in due categorie:
“quelli che raccontano” e “quelli che tacciono” e non v’è dubbio, come ha fatto notare Marco Belpoliti,
curatore del volume Conversazioni e interviste che egli sia tra i primi, per il suo impegno come oratore pubblico
e oggetto di interviste (terzo filone importante della sua personalità, insieme ai mestieri di chimico e di scrittore.)
Negare che comunicare si può è falso: si può sempre. Rifiutare di comunicare è colpa
, afferma Levi in I sommersi e i
salvati in un capitolo dedicato al tema della comunicazione (op.cit, p.69).
Infine in Storia di dieci giorni, capitolo finale del libro, il ritorno alla vita è rappresentato dalla rottura della
circolarità claustrofobica dello spazio concentrazionario quale Levi ci aveva descritto all’inizio del libro. Si tratta
dei due poli opposti dello stesso viaggio che inizia con la perdita di sé e si conclude con la riappropriazione di sé,
secondo un movimento circolare. La riconquista della propria dignità avviene dopo la rottura del filo spinato, fuori dal
reticolato, fuori dall’imbuto dell’inferno, quando ritornati uomini si può volgere di nuovo il viso verso l’alto e riveder
le stelle
(Inferno, canto XXXIV, v. 139).
C’è ancora un tema importante ed è quello dell’amicizia, partendo dalle dichiarazioni di Dante nelle Rime sul valore
dell’amicizia: relazione con Cavalcanti e gli altri poeti stilnovisti Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io
(Rime, IX), il suo rapporto con Virgilio, amico e guida, con Brunetto Latini (Inferno , XV) fino a Levi per
il quale l’amicizia permea tutti gli aspetti della vita.
Levi ce ne dà una definizione in una poesia poco nota intitolata Agli amici del 1985 nella quale i momenti di amicizia
diventano l’unità di misura della vita. La sua opera è costellata dal vocabolario e dalle immagini dell’amicizia: già nella
preghiera “Shemà” che apre Se questo è un uomo,
il cibo caldo e visi amici
contribuiscono a definire il mondo comune che è
l’antitesi del lager, poi c’è l’amicizia con l’inseparabile Alberto che scomparirà nella marcia di evacuazione del campo,
l’amicizia fraterna con l’operaio Lorenzo che lo aiuta a sopravvivere, ma anche l’amicizia che sente nei confronti lettori
(in Dello scrivere oscuro), per i libri e gli autori preferiti (in La ricerca delle radici) persino per i metalli
(“metalli amici” e “metalli nemici” in Il Sistema periodico). La rete di affinità che Levi tende a creare
tra gli elementi, la sua ricerca di un senso di comunità sono elementi costitutivi della sua sensibilità etica e di un
pensare all’antica
, come scrive Gordon, premoderno, o almeno "premodernista”
(Gordon, Primo Levi: le virtù dell’uomo normale, Carocci, Roma 2003, p. 193).
- BIBLIOGRAFIA
- D. Alighieri, La Divina Commedia, ( a cura di N. Sapegno), Nuova Italia, Firenze 1955
- P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1958
- P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986
- J. Améry, Intellettuale ad Auschwitz (1966), Adelphi, Milano 1987
- H. Arendt, La banalità del male Eichmann a Gerusalemme (1963), Feltrinelli, Milano 1964
- M. Belpoliti ( a cura di), Primo Levi, Marcos y Marcos, Milano 1997
- L. Mondo, Primo Levi e Dante, in Atti del Convegno internazionale di S. Salvatore Monferrato, 26-27 settembre 1991
- C. Segre, Se questo è un uomo, in Letteratura italiana. Il secondo Novecento, ( a cura di A.Asor Rosa), Einaudi , Torino 1996-2007
UNA STAGIONE ALL’INFERNO
di Arthur Rimbaud
Nell’aprile del 1873, all’età di 19 anni, di ritorno in Francia dall’Inghilterra, Arthur Rimbaud inizia a scrivere
Une saison en Enfer (Una stagione all’Inferno) che terminerà nell’agosto dello stesso anno.
L’opera esprime la profonda crisi in cui viene a trovarsi il poeta e rappresenta emblematicamente l’addio alla poesia
tradizionale.
“Addio L’autunno di già!... ma perché rimpiangere un eterno sole, se siamo impegnati nella scoperta della chiarezza divina, lontana da chi muore sulle stagioni.
L’autunno. La nostra barca alta nelle brume immobili volge verso il porto della miseria, la città enorme dal cielo chiazzato di fuoco e di fango. Ah! gli stracci putridi,il pane inzuppato di pioggia, l’ubriachezza, i mille amori che mi hanno crocefisso! Non la smetterà mai questa lamia, regina di milioni di anime e di corpi morti e che saranno giudicati! Mi rivedo con la pelle corrosa dal fango dalla peste, pieno di vermi i capelli e le ascelle e vermi ancor più grossi nel cuore, disteso tra gli sconosciuti senza età, senza sentimento … Avrei potuto morirci … Orrenda evocazione!...”
VIOLENZA SULLE DONNE:
il femicidio, l’omicidio di genere.
E’ uscita ad aprile sulla stampa la notizia che dall’inizio dell’anno, in Italia, già 50 donne sono state uccise, si ritiene che il dato sia inferiore alla realtà e che nel 2012 bisogna attendersi circa 150 casi di uccisione di donne.
I pochi dati disponibili si devono alla paziente ricerca di studiose sugli organi di informazione, è certamente strano che sia l’Istat che altri organismi pubblici non forniscano delle statistiche al riguardo, il femicidio non è solo una sottocategoria dell’omicidio, ma un vero e proprio modello di pensiero, quello che genericamente implica il possesso della persona amata, non si accetta, da parte degli esecutori, che un soggetto considerato più debole, si opponga alla propria volontà.
Casa delle donne in un lavoro pubblicato sul suo sito dal titolo Uomini che uccidono le donne. Indagine sul femicidio in
Italia
riporta una serie di dati raccolti consultando giornali nazionali e locali e sono ritenuti sottostimati.
| ANNO | NUMERO ASSOLUTO |
|---|---|
| 2011 | 120 |
| 2010 | 127 |
| 2009 | 119 |
| 2008 | 113 |
| 2007 | 103 |
| 2006 | 101 |
| 2005 | 84 |
| TOTALE | 767 |
IL GENOCIDIO in RWANDA
La guerra civile ruandese e il genocidio che ne derivò sono alcuni tra gli episodi più sanguinosi della storia del ventesimo secolo. Negli anni ’90, gli stati del Rwanda e del Burundi erano abitati per la maggioranza dall’etnia Hutu (pari al 90% della popolazione) ma governati dalla minoranza Tutsi.
La rigida divisione etnica, priva di qualsiasi fondamento, data la presenza di innumerevoli gruppi tribali, venne forzatamente istituzionalizzata durante il periodo coloniale a cavallo tra Ottocento e Novecento. I coloni tedeschi prima e quelli belgi poi, ai quali fu affidato il paese in seguito alla prima guerra mondiale con il sostegno dei missionari cattolici, introdussero apposite carte d’identità che classificavano una persona in base ai somatici e allo status sociale.
In tale contesto, i Tutsi beneficiarono di un trattamento preferenziale perché, oltre che maggiormente inclini ai canoni occidentali, erano più ricchi e ben disposti nei confronti dei dominatori europei, tanto da essere inseriti nell’amministrazione coloniale e considerati veri e propri uomini di fiducia cui affidare incarichi politici. Tra il 1959 e il 1961 la rivolta dell’etnia sottomessa degli Hutu, promossa dal movimento per l’emancipazione, riuscì a spodestare la classe dirigente Tutsi, ad abbattere la monarchia e a proclamare la repubblica, il 1 luglio 1962, con la dipartita del Belgio, il Ruanda conquistò l’indipendenza. La svolta politica avvenne però in maniera tutt’altro che pacifica: migliaia di persone morirono negli scontri interetnici e centinaia di Tutsi furono costretti a emigrare nei paesi limitrofi per non subire le persecuzioni e le vendette di natura razzista in risposta alla dominazione coloniale. Gli anni seguenti furono caratterizzati da ulteriori violenze, dove a partire dal 1973, il generale Hutu Juvenal Habyarimana instaurò un regime autoritario che si protrasse per più di vent’anni.
Verso la fine degli anni Ottanta, nella comunità Tutsi rifugiatasi in Uganda, nacque il Fronte patriottico ruandese (RPF), che si prefiggeva l’obiettivo di favorire il ritorno dei profughi in patria, anche attraverso la conquista militare del potere.
Il 4 agosto 1993, il presidente Habyarimana sottoscrisse un accordo che prevedeva il rientro dei profughi tutsi dal Burundi e
che concedeva ad alcuni membri del Fronte ruoli istituzionali e militari di rilievo.
Il 6 aprile 1994 i presidenti del Ruanda e del Burundi, entrambi di etnia Hutu, morirono in un misterioso incidente, l’aereo
sul quale viaggiavano fu colpito da un missile.
Per vendicare l’accaduto, nei giorni seguenti, nelle zone controllate dalleFAR,
le forze armate ruandesi, venne dato l’ordine,
per radio “di uccidere gli scarafaggi tutsi”; per cento giorni non ci fu tregua e furono uccise circa un milione di persone;
i carnefici non sono facilmente identificabili perché la direttiva era che ogni appartenente all’etnia Hutu avrebbe dovuto
partecipare attivamente al massacro o sarebbe stato ucciso a sua volta. Le persone coinvolte nel genocidio sono circa mezzo
milione tra mandanti, esecutori e persone coinvolte in crimini come lo stupro.
Né l’ONU né altri stati intervennero per fermare il massacro che ebbe termine intorno alla metà di luglio, con la vittoria
del RPF, guidato dall’odierno presidente Paul Kagame, sulle forze governative.
Nei mesi successivi si verificò un controesodo di massa, per paura di ritorsioni da parte dei Tutsi tornati al potere un
milione di Hutu scapparono verso i paesi confinanti.
Il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi in Ruanda sta portando avanti lentamente ma con efficacia il suo
delicato lavoro, ricercando e condannando i responsabili dei massacri.
BUSH RACCONTA l’11 SETTEMBRE
L’uomo che fu il fulcro delle decisioni prese dal governo Usa di fronte al più cruento attacco terroristico avvenuto sul suolo americano racconta la personale esperienza di quelle ore tragiche e dei giorni che seguirono all'11 settembre 2011.
A 10 anni dall'attentato, per la prima volta, l’ex presidente rivela le sue emozioni e i suoi pensieri: cosa lo guidò nelle decisioni prese nei minuti, le ore e i giorni seguenti l’attacco. Nella più accurata intervista che abbia mai rilasciato sull’argomento, Bush fornisce un resoconto intimo su ciò che dovette affrontare come comandante in capo incaricato di proteggere i propri concittadini e come padre di famiglia preoccupato per i suoi cari
Nell’intervista Bush ricostruisce gli eventi di quelle giornate: dal jogging mattutino alla visita alla scuola dove fu informato
dell’attacco; la difficoltà di trovarsi in un’aula piena di bambini e di fronte alla stampa; i primi tentativi per mettersi in
contatto con la nazione; le preoccupazioni dei Servizi Segreti relative alla sua sicurezza sull’Air Force One; il flusso di
informazioni provenienti dall’esercito, dall’intelligence e dagli organi di informazioni. Senza dimenticare la visita a
Ground Zero, avvenuta il 14 settembre: Dall’alto sembrava una gigantesca cicatrice – ricorda Bush. Ma quando mi recai sul luogo,
era come se stessi camminando all’inferno
. L’ex presidente confessa anche i timori personali, condivisi con il resto della
popolazione, legati alla sorte dei propri cari. Una delle mie preoccupazioni, simile a quella di tante persone, fu: mia moglie,
Laura, sta bene? E le mie figlie?
.
“L’11 settembre – conclude Bush – sarà un giorno che rimarrà segnato sul calendario. Come la giornata che ricorda Pearl Harbor.
Per quelli di noi che l’hanno vissuto, sarà un giorno che non dimenticheremo mai
.
Intervista rilasciata il 5/09/2011 a National Geographic Channel.
IGNAVI
Indice
- I. Kant
- A. Manzoni: Promossi sposi
- G. Flaubert: Madame Bovary
- E. Montale: Meriggire pallido e assorto
- L. Pirandello: Così è se vi pare
- A. Gramsci: Odio gli indifferenti
- I. Svevo: La coscienza di zeno
- A. Moravia: Gli indifferenti
- P. Levi: I sommersi e i salvati
- M. Medeiros: Lentamente Muore
- R. Saviano: Gomorra
- P. Colaprico: Caso Englaro
- F. Ervaz: Se ti abbraccio non aver paura
- D. Bignardi: Vanity Fair
Immanuel Kant
Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?(1784)
«Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro, Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d'intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'Illuminismo. »
"Se io ho un libro che pensa per me, se ho un direttore spirituale che pensa per me… io non ho più bisogno di darmi pensiero di me. Non ho bisogno pensare, purché possa solo pagare…". Gli interessati tutori imprigionano i vili e i pigri nella "carrozzina da bambini" paventando loro i rischi che si corrono a voler camminare da soli. Non s'impara a camminare senza cadere, ma questo li terrorizza, per cui rimarranno infanti per tutta la loro vita.
Alessandro Manzoni
I Promessi Sposi (1840)
Capitolo I
Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava alla parte d'un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dov'era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d'un ipsilon: quella a destra saliva verso il monte, e menava alla cura: l'altra scendeva nella valle fino a un torrente; e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggiero. I muri interni delle due viottole, in vece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell'intenzion dell'artista, e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevan dir fiamme; e, alternate con le fiamme, cert'altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio: anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com'era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno dirimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede posato sul terreno della strada; il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento, e quello che, dal luogo ov'era giunto il curato, si poteva distinguer dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi mustacchi arricciati in punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni: uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de' bravi. …
Capitolo II
Si racconta che il principe di Condé dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi: ma, in primo luogo, era molto affaticato; secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie, e stabilito ciò che dovesse fare, la mattina. Don Abbondio in vece non sapeva altro ancora se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia; quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell'intimazione ribalda, né delle minacce, e fare il matrimonio, era un partito, che non volle neppur mettere in deliberazione. Confidare a Renzo l'occorrente, e cercar con lui qualche mezzo... Dio liberi! - Non si lasci scappar parola... altrimenti... ehm! - aveva detto un di que' bravi; e, al sentirsi rimbombar quell'ehm! nella mente, don Abbondio, non che pensare a trasgredire una tal legge, si pentiva anche dell'aver ciarlato con Perpetua. Fuggire? Dove? E poi! Quant'impicci, e quanti conti da rendere! A ogni partito che rifiutava, il pover'uomo si rivoltava nel letto. Quello che, per ogni verso, gli parve il meglio o il men male, fu di guadagnar tempo, menando Renzo per le lunghe. Si rammentò a proposito, che mancavan pochi giorni al tempo proibito per le nozze; "e, se posso tenere a bada, per questi pochi giorni, quel ragazzone, ho poi due mesi di respiro; e, in due mesi, può nascer di gran cose". Ruminò pretesti da metter in campo; e, benché gli paressero un po' leggieri, pur s'andava rassicurando col pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatti parer di giusto peso, e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio sur un giovanetto ignorante. "Vedremo, - diceva tra sé: - egli pensa alla morosa; ma io penso alla pelle: il più interessato son io, lasciando stare che sono il più accorto. Figliuol caro, se tu ti senti il bruciore addosso, non so che dire; ma io non voglio andarne di mezzo". Fermato così un poco l'animo a una deliberazione, poté finalmente chiuder occhio: ma che sonno! che sogni! Bravi, don Rodrigo, Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate. Il primo svegliarsi, dopo una sciagura, e in un impiccio, è un momento molto amaro. La mente, appena risentita, ricorre all'idee abituali della vita tranquilla antecedente; ma il pensiero del nuovo stato di cose le si affaccia subito sgarbatamente; e il dispiacere ne è più vivo in quel paragone istantaneo. Assaporato dolorosamente questo momento, don Abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte, si confermò in essi, gli ordinò meglio, s'alzò, e stette aspettando Renzo con timore e, ad un tempo, con impazienza. Lorenzo o, come dicevan tutti, Renzo non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter, senza indiscrezione, presentarsi al curato, v'andò, con la lieta furia d'un uomo di vent'anni, che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era, fin dall'adolescenza, rimasto privo de' parenti, ed esercitava la professione di filatore di seta, ereditaria, per dir così, nella sua famiglia; professione, negli anni indietro, assai lucrosa; allora già in decadenza, ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Il lavoro andava di giorno in giorno scemando; ma l'emigrazione continua de' lavoranti, attirati negli stati vicini da promesse, da privilegi e da grosse paghe, faceva sì che non ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese. Oltre di questo, possedeva Renzo un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso, quando il filatoio stava fermo; di modo che, per la sua condizione, poteva dirsi agiato. E quantunque quell'annata fosse ancor più scarsa delle antecedenti, e già si cominciasse a provare una vera carestia, pure il nostro giovine, che, da quando aveva messi gli occhi addosso a Lucia, era divenuto massaio, si trovava provvisto bastantemente, e non aveva a contrastar con la fame. Comparve davanti a don Abbondio, in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale del manico bello, nel taschino de' calzoni, con una cert'aria di festa e nello stesso tempo di braverìa, comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovinotto. …
Capitolo IX
…Era essa l'ultima figlia del principe ***, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi ddla città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro; e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse, la storia non lo dice espressamente; fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservar la famiglia, a procrear cioè de' figliuoli, per tormentarsi a tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice era ancor nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca; decisione per la quale faceva bisogno, non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro, e che fosse stato portato da una santa d'alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano; poi santini che rappresentavan monache; e que' regali eran sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto; come cosa preziosa, e con quell'interrogare affermativo: - bello eh? - Quando il principe, o la principessa o il principino, che solo de' maschi veniva allevato in casa, volevano lodar l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovasser modo d'esprimer bene la loro idea, se non con le parole: - che madre badessa! - Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente, in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva a qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente, - tu sei una ragazzina, - le si diceva: - queste maniere non ti convengono: quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso -. Qualche altra volta il principe, riprendendola di cert'altre maniere troppo libere e famigliari alle quali essa trascorreva con uguale facilità, - ehi! ehi! - le diceva; - non è questo il fare d'una par tua: se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te: ricordati che tu devi essere, in ogni cosa, la prima del monastero; perché il sangue si porta per tutto dove si va. …
Capitolo X
… Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti. E neppure descriveremo, in particolare e per ordine, i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo: sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni, troppo monotona, e troppo somigliante alle cose già dette. L'amenità de' luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all'aria aperta, le rendevan più odiosa l'idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora eran l'impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un'invidia, un rodimento intollerabile; e talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che, nel sentirsi dare quel titolo, dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa de' palazzi, lo splendore degli addobbi, il brulichìo e il fracasso giulivo delle feste, le comunicavano un'ebbrezza, un ardor tale di viver lieto, che prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto, piuttosto che tornare all'ombra fredda e morta del chiostro. Ma tutte quelle risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta anche, il pensiero di dover abbandonare per sempre que' godimenti, gliene rendeva arnaro e penoso quel piccol saggio; come l'infermo assetato guarda con rabbia, e quasi rispinge con dispetto il cucchiaio d'acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria, e venne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne; concorsero, com'era da aspettarsi, i due terzi de' voti segreti ch'eran richiesti da' regolamenti; e Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora d'entrar più presto che fosse possibile, nel monastero. Non c'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà; e, condotta pomposamente al monastero, vestì l'abito. Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto; lo ripeté, e fu monaca per sempre. …
Gustave Flaubert
Madame Bovary(1856)
Parte Prima
Rodolfo sottopone Emma all’azione martellante del suo spudorato corteggiamento. Fanno insieme una passeggiata a cavallo nel bosco, che poi si sarebbe rivelata quella fatale, perché durante il suo svolgimento Rodolphe fa la sua professione d’amore. Ed ella, nella scontentezza della vita e nella debolezza della carne, si abbandona al corteggiamento del suo seduttore. Al rientro a casa mentisce al marito. Poi, per giustificare a se stessa prima ancora che agli altri il motivo della sua caduta, si costruisce un alibi psicologico tutto suo, rappresentandosi come la vittima sacrificale di un modello etico e comportamentale erroneo ed ipocrita. In pratica, se ella ha peccato, la colpa non è sua, ma degli altri, della società, della sua condizione esistenziale.
Eugenio Montale
Meriggiare pallido e assorto (1916)
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
Nelle crepe dei suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano
a sommo di minuscole biche.
Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com'è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Luigi Pirandello
Così è se vi pare (1917)
Scene ottava e nona
Scena ottava
Detti, la Signora Frola, tutti gli altri.
La signora Frola s'introduce tremante, piangente, supplicante, con un fazzoletto in mano, in mezzo alla ressa degli altri, tutti
esagitati.
Signora Frola:
Signori miei, per pietà! per pietà! Lo dica lei a tutti, signor Consigliere!
Agazzi:
Io le dico, signora, di andar via subito! Perché qua lei, per ora, non può stare!
Signora Frola:
(smarrita) E perché? perché?
Alla signora Amalia.
Mi rivolgo a lei, mia buona signora...
Amalia:
Ma guardi... guardi, c'è qua il Prefetto.
Signora Frola:
Oh! lei, signor Prefetto! Per pietà! Io volevo venire da lei!
Il Prefetto:
No, abbia pazienza, signora! Per ora io non posso darle ascolto. Bisogna che lei vada!
Signora Frola:
Sì, me ne vado! Me ne vado oggi stesso! Me ne parto, signor Prefetto! per sempre me ne parto!
Agazzi:
Ma no, in questo momento, sia buona, basta che lei si ritiri. Mi faccia la grazia! Poi parlerà col signor Prefetto!
Signora Frola:
Ma perché?... Che cos'è? Che cos'è?
Agazzi:
Deve tornare subito qua suo genero, ecco! Ha capito?
Signora Frola:
Ah! Sì?... E allora, sì... sì, mi ritiro... mi ritiro subito! Volevo dir loro questo soltanto: che per pietà, la finiscano!
Loro credono di farmi un bene, così, e mi fanno tanto male! Io sono costretta ad andarmene, così, a partirmene oggi stesso!
perché lui sia lasciato in pace! - Ma che vogliono, che vogliono ora qua da lui? Che deve venire a fare qua lui?...
- Oh, signor Prefetto!
Il Prefetto:
Niente, signora, stia tranquilla! Stia tranquilla, e se ne vada, per piacere...
Amalia:
Via, signora, sì! sia buona!
Signora Frola:
Ah Dio, signora mia, loro mi priveranno dell'unico bene, dell'unico conforto che mi restava: vederla almeno da lontano la mia
figliuola!
Si mette a piangere.
Il Prefetto:
Ma chi glielo dice? Perché? Lei non ha bisogno di partirsene! Le diciamo di ritirarsi ora per un momento. Stia tranquilla!
Signora Frola:
Ma è per lui! per lui, signor Prefetto! Io sono venuta qua a pregare tutti per lui, non per me!
Il Prefetto:
Sì, va bene... E lei può star tranquilla anche per lui, gliel'assicuro io. Vedrà che ora si accomoderà tutto...
Signora Frola:
E come? E come? Li vedo qua tutti accaniti addosso a lui!
Il Prefetto:
No, signora! Non è vero! Ci sono qua io per lui! Stia tranquilla!
Signora Frola:
Ah! Lei lo crede? Ah, grazie! Vuol dire che lei ha compreso...
Il Prefetto:
Sì, sì, signora, io ho compreso...
Signora Frola:
E io l'ho detto qua, a tutti questi signori... È una disgrazia già superata... veda! su cui non bisogna più ritornare...
Il Prefetto:
Sì, va bene, signora... Se le dico che io ho compreso!
Signora Frola:
Ecco, sì, signor Prefetto! Se ci costringe a vivere così - non importa! Non ci fa niente! Perché noi siamo contente... La mia
figliuola è contenta così, e questo mi basta!... - Ci pensi lei, ci pensi lei... perché, se no, non mi resta altro che andarmene,
proprio! e non vederla più, neanche così da lontano... Lo lascino in pace, per carità!
A questo punto, tra la ressa si fa un movimento d'ansia e di sgomento, tutti fanno cenni, alcuni guardano verso l'uscio; qualche
voce repressa si fa sentire.
VOCI:
Oh Dio... Eccola... Oh Dio...
Signora Frola:
(notando lo sgomento, lo scompiglio, geme perplessa, tremante) Che cos'è?... Che cos'è?
Scena nona
Detti, la Signora Ponza, poi il Signor Ponza.
Tutti si scostano da una parte e dall'altra per dar passo alla signora Ponza che si fa avanti rigida, in gramaglie, col volto
nascosto da un fitto velo nero, impenetrabile.
Signora Frola:
(cacciando un grido straziante di frenetica gioja) Ah! Lina... Lina... Lina...
E si precipita e s'avvinghia alla donna velata, con l'arsura d'una madre che da anni e anni non abbraccia più la sua figliuola.
Ma contemporaneamente, dall'interno, si odono le grida del signor Ponza che si precipita sulla scena.
Ponza:
Giulia!... Giulia!... Giulia!...
La signora Ponza, alle grida di lui, s'irrigidisce tra le braccia della signora Frola che la cingono. Il signor Ponza s'accorge
della suocera così perdutamente abbracciata alla moglie, e inveisce, furente.
Ah! Questo hanno fatto! L'avevo detto io! Si sono approfittati così, vigliaccamente, della mia buona fede?
Signora Frola:
(volgendo il capo velato, quasi con austera solennità, verso il marito) Non temere! - Non temere! Conducila via... -
Andate, andate...
Signora Frola:
(si stacca subito, da sé, tutta tremante, umile, dall'abbraccio, e accorre, premurosa, a lui)
Sì, sì... andiamo, caro, andiamo... andiamo...
E tutti e due abbracciati, carezzandosi a vicenda, tra due diversi pianti, si ritirano. Silenzio. Dopo aver seguito con gli occhi
fino all'ultimo i due, tutti si rivolgono ora sbigottiti e commossi alla signora velata.
Signora Frola:
Che altro possono voler da me, dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restar nascosta, perché solo
così può valere il rimedio che la pietà le ha prestato.
Il Prefetto:
(commosso) Ma noi vogliamo, vogliamo rispettar la pietà, signora... Vorremmo però che lei ci dicesse...
Signora Frola:
Che cosa? la verità: è solo questa: che io sono, sì, la figlia della signora Frola, - e la seconda moglie del signor Ponza; sì,
e per me nessuna! nessuna!
Il Prefetto:
Ah, no, per sé, lei, signora, sarà l'una o l'altra!
Signora Frola:
Nossignori. - Per me, io sono colei che mi si crede!
Guarda, attraverso il velo, tutti, fieramente, e si ritira. Un silenzio.
Laudisi:
Ecco, o signori, come parla la verità!
Volge attorno uno sguardo di sfida derisoria.
Siete contenti?
Scoppia a ridere
Ah! ah! ah! ah!
Tela.
Antonio Gramsci
Odio gli indifferenti
da La Città Futura (1917)
Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che "vivere vuol dire essere partigiani". Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. E' la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica.
L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E' la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano.
I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti,preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere. Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'èin essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento.
Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Italo Svevo
La coscienza di Zeno (1923)
Cap III
Il Fumo
Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato:
Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!
.
Era un'ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l'accompagnarono. M'ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch'è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. Quell'ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo.
Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge.
Pur troppo! Fu un errore e fu anch'esso registrato da un'ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa e mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo finalmente le catene del carbonio. M'ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco?
Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio, descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo di esser vissuto malato tutta la vita?
Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le pareti della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri.
Penso che la sigaretta abbia un gusto più intenso quand'è l'ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. L'ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su sé stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute permane, ma va un po' più lontano.
Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più varii ed anche ad olio. Il proponimento, rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata espressione nella forza del colore che doveva far impallidire quello dedicato al proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza delle cifre. Del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio: "Nono giorno del nono mese del 1899". Significativa nevvero? Il secolo nuovo m'apportò delle date ben altrimenti musicali: "Primo giorno del primo mese del 1901". Ancor oggi mi pare che se quella data potesse ripetersi, io saprei iniziare una nuova vita.
Ma nel calendario non mancano le date e con un po' d'immaginazione ognuna di esse potrebbe adattarsi ad un buon proponimento. Ricordo, perché mi parve contenesse un imperativo supremamente categorico, la seguente: "Terzo giorno del sesto mese del 1912 ore 24". Suona come se ogni cifra raddoppiasse la posta.
L'anno 1913 mi diede un momento d'esitazione. Mancava il tredicesimo mese per accordarlo con l'anno. Ma non si creda che occorrano tanti accordi in una data per dare rilievo ad un'ultima sigaretta.
Alberto Moravia
Gli indifferenti (1929)
Capitolo II
"Non pensare a me, mamma"disse con fermezza; "io non c'entro nè ci voglio
entrare in tutto questo".
Fu in questo momento che una risata agra, falsa da allegare i denti parti dall'angolo
dove sedeva Michele; la madre si voltò: "Ma sai", egli le disse tentando con forzo di
dare alla sua voce indifferente un'intonazione sarcastica; "chi sarà il primo ad
abbandonarci se lasciamo la villa? Indovina".
"Mah, non so".
"Leo" egli proruppe additando l'uomo; "il nostro Leo".
Leo ebbe un gesto di protesta. " Ah, Merumeci? " ripeté la madre incerta e
impressionata guardando l'amante come se avesse voluto leggergli in faccia se fosse stato
capace di un simile tradimento; poi ad un tratto, con occhi e sorriso infiammati di patetico
sarcasmo: " Ma già... sicuro... e io stupida che non ci pensavo... sicuro Carla " soggiunse
rivolgendosi alla figlia; " Michele ha ragione... il primo che fingerà di non averci mai
conosciuto, dopo naturalmente che avrà intascato i quattrini, sarà Merumeci...: non
protesti " ella continuò con un sorriso ingiurioso; " non è colpa sua, tutti gli uomini sono
cosi... potrei giurarlo, passerà con una di quelle sue amiche tanto simpatiche e tanto
eleganti e appena mi vedrà... volterà la testa dall'altra parte... sicuro... caro lei... ci
metterei la mano sul fuoco... ". Tacque per un istante. " E già ", concluse con amarezza e rassegnazione;
" già... anche Cristo è stato tradito dai suoi migliori amici ".
Primo Levi
I Sommersi e i Salvati (1986)
La zona grigia della «protekcja» e della collaborazione nasce da radici molteplici. In primo luogo, l’area del potere, quanto più è ristretta, tanto più ha bisogno di ausiliari esterni; il nazismo degli ultimi anni non ne poteva fare a meno, risoluto com’era a mantenere il suo ordine all’interno dell’Europa sottomessa, e ad alimentare i fronti di guerra dissanguati dalla crescente resistenza militare degli avversari. Era indispensabile attingere dai paesi occupati non solo mano d’opera, ma anche forze d’ordine, delegati ed amministratori del potere tedesco ormai impegnato altrove fino all’esaurimento. Entro quest’area vanno catalogati, con sfumature diverse per qualità e peso, Quisling di Norvegia, il governo di Vichy in Francia, il Judenrat di Varsavia, la Repubblica di Salò, fino ai mercenari ucraini e baltici impiegati dappertutto per i compiti più sporchi (mai per il combattimento), ed ai Sonderkommandos di cui dovremo parlare. Ma i collaboratori che provengono dal campo avversario, gli ex nemici, sono infidi per essenza: hanno tradito una volta e possono tradire ancora. Non basta relegarli in compiti marginali; il modo migliore di legarli è caricarli di colpe, insanguinarli, comprometterli quanto più è possibile: così avranno contratto coi mandanti il vincolo della correità, e non potranno più tornare indietro. Questo modo di agire è noto alle associazioni criminali di tutti i tempi e luoghi, è praticato da sempre dalla mafia, e tra l’altro è il solo che spieghi gli eccessi, altrimenti indecifrabili, del terrorismo italiano degli anni ‘70.
In secondo luogo, ed a contrasto con una certa stilizzazione agiografica e retorica, quanto più è dura l’oppressione, tanto più è
diffusa tra gli oppressi la disponibilità a collaborare col potere. Anche questa disponibilità è variegata da infinite sfumature e
motivazioni: terrore, adescamento ideologico, imitazione pedissequa del vincitore, voglia miope di un qualsiasi potere, anche
ridicolmente circoscritto nello spazio e nel tempo, viltà, fino a lucido calcolo inteso a eludere gli ordini e l’ordine imposto.
Tutti questi motivi, singolarmente o fra loro combinati, sono stati operanti nel dare origine a questa fascia grigia, i cui
componenti, nei confronti dei non privilegiati, erano accomunati dalla volontà di conservare e consolidare il loro privilegio.
Prima di discutere partitamente i motivi che hanno spinto alcuni prigionieri a collaborare in varia misura con l’autorità dei Lager,
occorre però affermare con forza che davanti a casi umani come questi è imprudente precipitarsi ad emettere un giudizio morale.
Deve essere chiaro che la massima colpa pesa sul sistema, sulla struttura stessa dello Stato totalitario; il concorso alla colpa
da parte dei singoli collaboratori grandi e piccoli (mai simpatici, mai trasparenti!) è sempre difficile da valutare. É un
giudizio che vorremmo affidare soltanto a chi si è trovato in circostanze simili, ed ha avuto modo di verificare su se stesso che
cosa significa agire in stato di costrizione. Lo sapeva bene il Manzoni: «I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in
qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano l’animo
degli offesi». La condizione di offeso non esclude la colpa, e spesso questa è obiettivamente grave, ma non conosco tribunale
umano a cui delegarne la misura.
Se dipendesse da me, se fossi costretto a giudicare, assolverei a cuor leggero tutti coloro per cui il concorso nella colpa è stato minimo, e su cui la costrizione è stata massima. Intorno a noi, prigionieri senza gradi, brulicavano i funzionari di basso rango. Costituivano una fauna pittoresca: scopini, lava-marmitte, guardie notturne, stiratori dei letti (che sfruttavano a loro minuscolo vantaggio la fisima tedesca delle cuccette rifatte piane e squadrate), controllori di pidocchi e di scabbia, portaordini, interpreti, aiutanti degli aiutanti. In generale, erano poveri diavoli come noi, che lavoravano a pieno orario come tutti gli altri, ma che per mezzo litro di zuppa in più si adattavano a svolgere queste ed altre funzioni « terziarie»: innocue, talvolta utili, spesso inventate dal nulla. Raramente erano violenti, ma tendevano a sviluppare una mentalità tipicamente corporativa, ed a difendere con energia il loro «posto di lavoro» contro chi, dal basso o dall’alto, glie lo insidiava. Il loro privilegio, che del resto comportava disagi e fatiche supplementari, fruttava loro poco, e non li sottraeva alla disciplina ed alle sofferenze degli altri; la loro speranza di vita era sostanzialmente uguale a quella dei non privilegiati. Erano rozzi e protervi, ma non venivano sentiti come nemici.
Il giudizio si fa più delicato e più vario per coloro che occupavano posizioni di comando: i capi (Kapòs: il termine tedesco deriva direttamente da quello italiano, e la pronuncia tronca, introdotta dai prigionieri francesi, si diffuse solo molti anni dopo, divulgata dall’omonimo film di Pontecorvo, e favorita in Italia proprio per il suo valore differenziale) delle squadre di lavoro, i capibaracca, gli scritturali, fino al mondo (a quel tempo da me neppure sospettato) dei prigionieri che svolgevano attività diverse, talvolta delicatissime, presso gli uffici amministrativi del campo, la Sezione Politica (di fatto, una sezione della Gestapo), il Servizio del Lavoro, le celle di punizione. Alcuni fra questi, grazie alla loro abilità o alla fortuna, hanno avuto accesso alle notizie più segrete dei rispettivi Lager, e, come Hermann Langbein ad Auschwitz, Eugen Kogon a Buchenwald, e Hans Marsalek a Mauthausen, ne sono poi diventati gli storici. Non si sa se ammirare di più il loro coraggio personale o la loro astuzia, che ha concesso loro di aiutare concretamente i loro compagni in molti modi, studiando attentamente i singoli ufficiali delle SS con cui erano a contatto, ed in-tuendo quali fra questi potessero essere corrotti, quali dissuasi dalle decisioni più crudeli, quali ricattati, quali ingannati, quali spaventati dalla prospettiva di un redde rationem a guerra finita. Alcuni fra loro, ad esempio i tre nominati, erano anche membri di organizzazioni segrete di difesa, e perciò il potere di cui disponevano grazie alla loro carica era controbilanciato dal pericolo estremo che correvano, in quanto «resistenti» e in quanto detentori di segreti.
I funzionari ora descritti non erano affatto, o erano solo apparentemente, dei collaboratori, bensì piuttosto degli oppositori mimetizzati. Non così la maggior parte degli altri detentori di posizioni di comando, che si sono rivelati esemplari umani da mediocri a pessimi. Piuttosto che logorare, il potere corrompe; tanto più intensamente corrompeva il loro potere, che era di natura peculiare.
Lentamente muore
(il testo della poesia è di Martha Medeiros, giornalista e scrittrice brasiliana nata nel 1961 e erroneamente attribuita a Pablo Neruda) (2000)
Lentamente muore
chi diventa schiavo dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,
chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco
e i puntini sulle “i”
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l’incertezza per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita, di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge,
chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare
chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza
porterà al raggiungimento
di una splendida felicità.
Roberto Saviano
Gomorra (2006)
I cinesi morti trasportati nei container
"I portelloni mal chiusi si aprirono di scatto e iniziarono a piovere decine di corpi. Uscivano dai container uomini e donne. Morti. Erano i cinesi che non muoiono mai." "Il container dondolava mentre la gru lo spostava sulla nave. Come se stesse galleggiando nell'aria, lo sprider, il meccanismo che aggancia il container alla gru, non riusciva a dominare il movimento. I portelloni mal chiusi si aprirono di scatto e iniziarono a piovere decine di corpi. Sembravano manichini. Ma a terra le teste si spaccavano come fossero crani veri. Ed erano crani. Uscivano dal container uomini e donne. Anche qualche ragazzo. Morti. Congelati, tutti raccolti, l'uno sull'altro. In fila, stipati come aringhe in scatola. Erano i cinesi che non muoiono mai. Gli eterni che si passano i documenti l'uno con l'altro. Ecco dove erano finiti. I corpi che le fantasie più spinte immaginavano cucinati nei ristoranti, sotterrati negli orti d'intorno alle fabbriche, gettati nella bocca del Vesuvio. Erano li'. Ne cadevano a decine dal container, con il nome appuntato su un cartellino annodato a un laccetto intorno al collo. Avevano tutti messo da parte i soldi per farsi seppellire nelle loro citta' in Cina. Si facevano trattenere una percentuale dal salario, in cambio avevano garantito un viaggio di ritorno, una volta morti. Uno spazio in un container e un buco in qualche pezzo di terra cinese. Quando il gruista del porto mi raccontò la cosa, si mise le mani in faccia e continuava a guardarmi attraverso lo spazio tra le dita ... ... Aveva soltanto fatto toccare terra al container, e decine di persone comparse dal nulla avevano rimesso dentro tutti e con una pompa ripulito i resti. Era cosi' che andavano le cose."
Piero Colaprico, La Repubblica 14 Novembre 2008
Caso Englaro, ecco la sentenza. Ora il malato può sceglier
MILANO - Con la sentenza di ieri, la Cassazione sembra aver dato ai cittadini un po' più di potere sui medici. Il cardine della sentenza Englaro è il "consenso informato" e cioè il fatto che il paziente può accettare o rifiutare le cure, una volta che il medico gli ha spiegato che cosa succede. La Cassazione si era occupata di questo tema negli anni Novanta, quando alcuni pazienti, scontenti del medico, l'avevano citato in giudizio. E erano state sentenze "a cose fatte". La novità è che, in questo caso specifico, il "consenso" ferma la mano del medico: no al trattamento, no alla nutrizione forzata, no alle cure che non portano a niente.
In altre parole, la libertà di coscienza del medico resta intatta, ma il paziente può dire no a quanto ritiene "invasivo".
Inoltre la Cassazione non ha esitazioni, questo rifiuto delle cure (pagina 6) "non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia".
L'eutanasia è infatti un "comportamento che intende abbreviare la vita". Mentre esiste "un atteggiamento di scelta, da parte
del malato, che la malattia segua il suo corso naturale".
Sulla condizione fisica e mentale di Eluana c'è una relazione "di sicuro valore scientifico" (pagina 13).
E nemmeno la procura generale ha sollevato la questione sulla "volontà presunta di Eluana", dandola per scontata. Anche questo è un
punto importante, perché non pochi politici discutono ancora se questa volontà di rifiutare le cure sia valida o no: per sentenza,
nata dopo un'indagine, questa volontà c'era, è stata verificata attraverso le testimonianze, dunque è valida.
Il ricorso viene rigettato perché i magistrati (la procura generale che ha fatto ricorso) non hanno da tutelare un interesse
generale nel caso di Eluana: perché è il caso umano, giudiziario, clinico di una singola persona.
Fulvio Ervaz
Se ti abbraccio non aver paura
 Fulvio Ervaz: Se ti abbraccio non aver paura
Fulvio Ervaz: Se ti abbraccio non aver paura
Chiara Sirianni
Tempimaggio 2012
Fulvio Ervas è la penna del romanzo “Se ti abbraccio non avere paura”. E venuto a contatto con la storia di Franco nel 2010: «A settembre era tornato dal suo viaggio, aveva il desiderio di mettere ordine ai suoi appunti, e probabilmente aveva la sensazione di aver fatto un’impresa originale e importante, per sé e per suo figlio». Attraverso un amico comune si incontrano, e inizia un lavoro, durato quasi due anni, di elaborazione sull’esperienza vissuta.
«Insegno in una scuola superiore in cui accogliamo, cercando di farlo al meglio, diversi studenti con disabilità» spiega Ervas a tempi.it. «La vita è piena di sfumature, E questi ragazzi ne sono espressione piena. La condizione emotiva di un ragazzo autistico non mi è estranea, pur non essendo un esperto. Mi ha colpito Andrea, la sua fisicità, la sua eleganza gestuale, certi sguardi profondissimi, anche se sfuggenti. E mi ha colpito Franco».
Perché? «Ogni genitore che abbia un atteggiamento positivo verso i propri figli mi colpisce. Un padre che decide, anche contro molti pareri, di uscire dagli schemi, di esplorare più a fondo l’autismo dei figlio ed esplorare sé come uomo e come padre, può non colpirti?
E poteva lasciare indifferente uno che dice: cosa può succedere ad un padre con un figlio autistico, girando per il mondo, di più complicato di quanto stia già affrontando quotidianamente? Gli ostacoli non sono nei chilometri ma nel difficile rapporto con questa malattia».
Tra i due si è creato un rapporto solidale, come capita spesso tra due padri: «Siamo due persone che per i propri figli qualche faticaccia se la sopportano volentieri. Perché p stato questo, il punto da cui abbiamo iniziato a costruire». Un altro elemento in comune è stata una sensibilità molto simile: «Niente piagnistei. Si possono fare, se uno lo desidera, noi no. Pensare al domani, sentire che si ha la forza di reagire e non subire. È il rapporto tra due viandanti, ciascuno con il suo particolare allenamento, la sua conoscenza del percorso, le sue illusioni, i suoi sogni, ma entrambi capaci di camminare fianco a fianco, per un tratto, raccontandosi cose della vita che si ascoltano solo poche volte, solo su certe strade. Solo da certe persone. E che ti fanno crescere»
Daria Bignardi
Vanity Fair giugno 2012
Il sorriso di Andrea che sa ricevere ma non trasmettere
Da settimane nella classifica dei best seller c’è il libro di un piccolo editore di Milano. Non parla di diete o cucina, non è un
giallo, il suo autore non è tra i più conosciuti. Parla di un viaggio estivo: il lungo viaggio tra gli Stati Uniti e l’America
Latina di Franco e Andrea Antonello.
Franco l’ho conosciuto un giorno di marzo. Avevo appuntamento in redazione con il padre di un ragazzo autistico: stava per uscire
il libro sulla loro storia e volevo capire se invitarlo alle Invasioni. Entrai in sala riunioni e ci trovai Ligabue. Feci finta di
niente perché non poteva essere lui, anche se era identico. Cominciammo a parlare: con un forte accento veneto il sosia di Ligabue si mise a spiegare che il suo bellissimo e normalissimo figlio Andrea a due anni e mezzo era diventato strano, l’avevano fatto visitare e dopo qualche mese gli avevano diagnosticato l’autismo. Da allora Franco, che faceva l’imprenditore, si era dedicato quasi completamente ad Andrea.
Lo raccontava con una luce degli occhi che non so descrivere. Una luce da innamorato pazzo. Da quel giorno ho rivisto Franco
Antonello altre tre volte: in una di queste mi ha presentato Andrea, che oggi ha 18 anni, è sempre bellissimo, ed è autistico.
«È come una trasmittente che può ricevere ma non riesce a trasmettere», dice Franco.
Non è facile capire quanto debba essere angosciante la condizione di Andrea: è così sorridente, affettuoso e giocherellone che
si potrebbe pensare sia felice. Purtroppo non lo è. Immaginate di non poter esprimere quello che avete dentro. Avete paura, fame,
sonno, mal di testa, amate o odiate qualcuno, e non sapete come comunicarlo.
Andrea qualche volta scrive quel che non riesce a dire sul computer, tramite la scrittura guidata: «Sono un uomo imprigionato nei
pensieri di libertà. Andrea vuole guarire», oppure: «Non è facile sentirsi pecora nera. Andrea vuole parlare. Vedo le parole e non
riesco a dirle», o ancora: «Chiedo scusa a tutti Andrea sta male di non controllo capace».
Il libro che racconta la storia di Franco e Andrea e il loro viaggio – un viaggio matto se pensate che solitamente i medici
consigliano agli autistici una vita protetta – l’ha scritto molto bene Fulvio Ervas. S’intitola Se ti abbraccio non aver paura,
perché Andrea quando incontra una persona nuova spesso l’abbraccia e le tocca la pancia. Suo padre cerca di spiegargli che non
deve farlo. Andrea, sul computer, scrive: «Sento la pancia di persone per conoscere chi mi sta vicino. Se non tocco mi agito».
La storia che Franco ha raccontato a Ervas è talmente forte, drammatica, ma anche gioiosa e sorprendente – e Franco la sa
comunicare con tanta intensità, e determinazione di aiutare gli altri ragazzi nelle condizioni di Andrea – che non avevo dubbi
sul successo del libro. Probabilmente non ne aveva nemmeno l’editore, Marcos y Marcos. Dieci ristampe, cinque lingue e quasi
certamente un film. Ma soprattutto un’attenzione costante che non dice solo che Se ti abbraccio non aver paura è un libro
riuscito, la famiglia di Franco Antonello speciale e l’autismo una malattia di cui si parla sempre più: mi sembra dica che non
potere e non sapere comunicare le proprie emozioni e i propri sentimenti è la grande paura e il grande problema di tanti.
L’autismo è una malattia che cominciamo da poco a conoscere meglio ma i comportamenti di tipo autistico sembrano connessi
ed evidenziati come pochi dalla contemporaneità.
AMORI DIFFICILI
Indice
- G. Boccaccio: Decameron
- G. Verga: I Malavaglia
- J. Prevert: le foglie morte
- N. Ikmet: Addio
- I. Calvino: L'avventura di due sposi
- D. Carboni: Monica
Giovanni Boccaccio
Decameron (1349 – 1353)
Quinta novella, quarta giornata
Lisabetta da Messina
Testo
I fratelli dell'Isabetta uccidon l'amante di lei; egli l'apparisce in sogno e mostrale dove sia sotterrato. Ella occultamente
disotterra la testa e mettela in un testo di bassilico; e quivi su piagnendo ogni dì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono,
ed ella se ne muore di dolore poco appresso.
Finita la novella d'Elissa, e alquanto dal re commendata, a Filomena fu imposto che ragionasse; la quale, tutta piena di
compassione del misero Gerbino e della sua donna, dopo un pietoso sospiro incominciò.
La mia novella, graziose donne, non sarà di genti di sì alta condizione, come costoro furono de'quali Elissa ha raccontato, ma ella per avventura non sarà men pietosa; e a ricordarmi di quella mi tira Messina poco innanzi ricordata, dove l'accidente avvenne.
Erano adunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il qual fu da San Gimignano, e avevano una lor sorella chiamata Lisabetta, giovane assai bella e costumata, la quale, che che se ne fosse cagione, ancora maritata non aveano.
E avevano oltre a ciò questi tre fratelli in uno lor fondaco un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte l'Isabetta guatato, avvenne che egli le 'ncominciò stranamente a piacere.
Di che Lorenzo accortosi e una volta e altra, similmente, lasciati suoi altri innamoramenti di fuori, incominciò a porre l'animo a lei; e sì andò la bisogna che, piacendo l'uno all'altro igualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più disiderava ciascuno.E in questo continuando e avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non seppero sì segretamente fare che una notte, andando l'Isabetta là dove Lorenzo dormiva, che il maggior de'fratelli, senza accorgersene ella, non se ne accorgesse. Il quale, per ciò che savio giovane era, quantunque molto noioso gli fosse a ciò sapere, pur mosso da più onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo intorno a questo fatto, infino alla mattina seguente trapassò.
Poi, venuto il giorno, a'suoi fratelli ciò che veduto avea la passata notte dell'Isabetta e di Lorenzo raccontò, e con loro insieme, dopo lungo consiglio, diliberò di questa cosa, acciò che né a loro né alla sirocchia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene tacitamente e d'infignersi del tutto d'averne alcuna cosa veduta o saputa infino a tanto che tempo venisse nel qua le essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna, avanti che più andasse innanzi, si potessero torre dal viso.
E in tal disposizion dimorando, così cianciando e ridendo con Lorenzo come usati erano avvenne che, sembianti faccendo d'andare fuori della città a diletto tutti e tre, seco menarono Lorenzo; e pervenuti in un luogo molto solitario e rimoto, veggendosi il destro, Lorenzo, che di ciò niuna guardia prendeva, uccisono e sotterrarono in guisa che niuna persona se ne accorse. E in Messina tornati dieder voce d'averlo per lor bisogne mandato in alcun luogo; il che leggiermente creduto fu, per ciò che spesse volte eran di mandarlo attorno usati.
Non tornando Lorenzo, e l'Isabetta molto spesso e sollicitamente i fratei domandandone, sì come colei a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno che, domandandone ella molto instantemente, che l'uno de'fratelli le disse:
- Che vuol dir questo? Che hai tu a fare di Lorenzo, ché tu ne domandi così spesso? Se tu ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene.
Per che la giovane dolente e trista, temendo e non sappiendo che, senza più domandarne si stava, e assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse, e alcuna volta con molte lagrime della sua lunga dimora si doleva e, senza punto rallegrarsi, sempre aspettando si stava.
Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava, ed essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato e con panni tutti stracciati e fracidi indosso, e parvele che egli dicesse:
- O Lisabetta, tu non mi fai altro che chiamare e della mia lunga dimora t'attristi, e me con le tue lagrime fieramente accusi; e per ciò sappi che io non posso più ritornarci, per ciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m'uccisono. E disegnatole il luogo dove sotterrato l'aveano, le disse che più nol chiamasse né l'aspettasse, e disparve.
E servando la giovane questa maniera del continuo, più volte da'suoi vicini fu veduta. Li quali, maravigliandosi i fratelli della sua guasta bellezza e di ciò che gli occhi le parevano della testa fuggiti, il disser loro:
- Noi ci siamo accorti, che ella ogni dì tiene la cotal maniera.
Il che udendo i fratelli e accorgendosene, avendonela alcuna volta ripresa e non giovando, nascosamente da lei fecer portar via questo testo. Il quale, non ritrovandolo ella, con grandissima instanzia molte volte richiese; e non essendole renduto, non cessando il pianto e le lagrime, infermò, né altro che il testo suo nella infermità domandava.
I giovani si maravigliavan forte di questo addimandare e per ciò vollero vedere che dentro vi fosse; e versata la terra, videro il drappo e in quello la testa non ancor sì consumata che essi alla capellatura crespa non conoscessero lei esser quella di Lorenzo. Di che essi si maravigliaron forte e temettero non questa cosa si risapesse; e sotterrata quella, senza altro dire, cautamente di Messina uscitisi e ordinato come di quindi si ritraessono, se n'andarono a Napoli.
La giovane non restando di piagnere e pure il suo testo addimandando, piagnendo si morì; e così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi a certo tempo divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcuno che compuose quel la canzone la quale ancora oggi si canta, cioè:
Quale esso fu lo malo cristiano,
che mi furò la grasta, ecc.
Parafrasi
C’erano a Messina tre giovani fratelli mercanti, i quali dopo la morte del padre originario di S. Giminiano, rimasero molto
ricchi. Questi avevano una sorella giovane, bella, costumata ed in età di marito, il suo nome era Elisabetta.
Oltre a questo i tre fratelli possedevano un magazzino il quale era gestito un giovane pisano chiamato Lorenzo bello e leggiadro,
per questo Elisabetta incominciò a guardarlo ed a invaghirsi di lui. Accortosi di questo, Lorenzo, lasciò da parte tutti i suoi
innamoramenti estranei alla casa e cominciò a pensare a lei, e piacendosi l’un con l’altra, fecero quello che entrambi desideravano
di più. Continuando così, avendo insieme piacere e buon tempo, non seppero farlo segretamente tanto che una sera andando
Elisabetta dove dormiva Lorenzo, il fratello maggiore li scoprì, senza che loro se ne accorgessero.
Il fratello maggiore che era giovane e intelligente pensò all’accaduto fino alla mattina seguente senza farne parola con nessuno,
anche se questo era per lui molto noioso.
Non vedendo tornare Lorenzo, Elisabetta continuava a chiedere spiegazioni ai fratelli e un giorno chiedendo ad uno di essi con
insistenza egli le disse:” Che vuol dire ciò? Che hai a che fare tu con Lorenzo? E come mai chiedi di lui cosi spesso? Se tu non
ci chiederai più niente noi ti daremo la risposta che cerchi.”
La giovane dolente e triste non sapendo più cosa fare o dire, non chiese più nulla ai fratelli, ma la notte lo chiamava e pregava
perché tornasse, e piangendo per il suo lungo ritardo lo aspettava. Dopo una notte passata a piangere per Lorenzo, egli le apparve
nel sonno, pallido e scarmigliato, con i vestiti fradici e stracciati e le parve che le dicesse:” O Elisabetta, tu piangi per
il mio ritardo e mi dai la colpa per le tue lacrime, perciò sappi che io non posso più tornare, perché i tuoi fratelli mi hanno
ucciso” e indicatole il posto in cui era sotterrato le disse di non chiamarlo più e di non aspettarlo, poi sparì.
La giovane, credendo nella visione, pianse amaramente; poi la mattina seguente disse nulla ai suoi fratelli ma voleva andare nel
luogo mostratole da Lorenzo per vedere se ciò che gli era apparso nel sonno era vero. Avuto il permesso di uscire da Messina,
in compagnia di una donna che era stata al loro servizio in passato, se ne andò.
Tolse le foglie secche che c’erano sul luogo e dove la terra le sembrava più morbida scavò, di li a poco trovò il corpo del suo
amante non ancora putrefatto, capì allora che la visione era giusta.
Era addolorata ma sapeva che quello non era ne il tempo ne il luogo adatto per piangere. Non potendo portare con se tutto il
corpo per dargli una sepoltura migliore, con un coltello gli tagliò la testa, la mise in un asciugatoio e la mise in braccio alla
signora, poi ricoprì il corpo con la terra e senza essere vista partì da quel luogo per casa sua.
Giunta a casa si rinchiuse in camera sua con la testa di Lorenzo e pianse a lungo, tanto da lavarla completamente, e la riempì di
mille baci da ogni parte..
Prese poi un bel vaso che si usava per piantarci la maggiorana o il basilico e vi ripose la testa fasciata in un lenzuolo, la
ricoprì poi di terra e vi piantò molti semi di basilico salernitano che innaffiava solo con acqua rosata, acqua di fiori d’arancio
o con le sue lacrime. Aveva l’abitudine di sedersi vicino al vaso e di fantasticare accanto ad esso; quanto aveva finito piangeva
a lungo e in questo modo innaffiava il basilico.
Questo sia per le continue attenzioni che per la terra molto grassa divenne bello e profumato. I vicini notarono Elisabetta durante
questo momento, che si ripeteva spesso, sia dal suo strano viso che dai suoi occhi incavati e le dissero:” noi ci siamo accorti
che lei ogni giorno fa la stessa cosa”.
I fratelli sentito questo rimproverarono la sorella e le fecero portare via il vaso; la ragazza non lo trovava più e molte volte
lo chiese ai suoi fratelli ma essi non glielo ridavano, lei non cessava mai di cercarlo e di piangere chiedendo del vaso.
I fratelli si meravigliarono di queste continue domande e perciò vollero controllare cosa ci fosse nel vaso; svuotarono questo e
trovato il lenzuolo lo aprirono e videro la testa non ancora consumata, ma la riconobbero a causa della capigliatura crespa.
Essi rimasero meravigliati da questo e temendo che si sapesse in giro sotterrarono la testa e lasciarono Messina, ritirandosi da
ogni attività commerciale, per trasferirsi a Napoli.
La giovane non cessava di piangere e continuava a chiedere del vaso, fu così che morì piangendo e che finì il suo sfortunato
amore. Ma poi la faccenda divenne conosciuta da molti e qualcuno compose quella canzone che ancora oggi si canta:” quale fu il
male cristiano, che mi rubò il vaso ecc…”
Giovanni Verga
I Malavoglia (1881)
“Mena e Alfio” da cap. XV.
Giacché tutti si maritavano, Alfio Mosca avrebbe voluto prendersi comare Mena, che nessuno la voleva più, dacché la casa dei
Malavoglia s'era sfasciata, e compar Alfio avrebbe potuto dirsi un bel partito per lei, col mulo che ci aveva; così la domenica
ruminava fra di sé tutte le ragioni per farsi animo, mentre stava accanto a lei, seduto davanti alla casa, colle spalle al muro a
sminuzzare gli sterpolini della siepe per ingannare il tempo. Anche lei guardava la gente che passava, e così facevano festa la
domenica: - Se voi mi volete ancora, comare Mena - disse finalmente; - io per me son qua. La povera Mena non si fece neppur rossa,
sentendo che compare Alfio aveva indovinato che ella lo voleva, quando stavano per darla a Brasi Cipolla, tanto le pareva che quel
tempo fosse lontano, ed ella stessa non si sentiva più quella.
- Ora sono vecchia, compare Alfio, - rispose, - e non mi marito più.
- Se voi siete vecchia, anch'io sono vecchio, ché avevo degli anni più di voi, quando stavamo a chiacchierare dalla finestra, e mi
pare che sia stato ieri, tanto m'è rimasto in cuore. Ma devono esser passati più di otto anni. E ora quando si sarà maritato vostro
fratello Alessi, voi restate in mezzo alla strada.
Mena si strinse nelle spalle, perché era avvezza a fare la volontà di Dio, come la cugina Anna; e compare Alfio, vedendo cosi,
riprese:
- Allora vuol dire che non mi volete bene, comare Mena, e scusatemi se vi ho detto che vi avrei sposata. Lo so che voi siete nata
meglio di me, siete figlia di padroni; ma ora non avete più nulla, e se si marita vostro fratello Alessi, rimarrete in mezzo alla
strada. Io ci ho il mulo e il mio carro, e il pane non ve lo farei mancare giammai, comare Mena. Ora perdonatemi la libertà!
- Non mi avete offesa, no, compare Alfio; e vi avrei detto di sì anche quando avevamo la Provvidenza e la casa del nespolo, se i
miei parenti avessero voluto, che Dio sa quel che ci avevo in cuore quando ve ne siete andato alla Bicocca col carro dell'asino, e
mi pare ancora di vedere quel lume nella stalla, e voi che mettevate tutta la vostra roba sul carretto, nel cortile; vi rammentate?
- Sì, che mi rammento! Allora perché non mi dite di sì, ora che non avete più nulla, e ci ho il mulo invece dell'asino al carretto,
e i vostri parenti non potrebbero dir di no?
- Ora non son più da maritare; - tornava a dire Mena col viso basso, e sminuzzando gli sterpolini della siepe anche lei.
- Ho ventisei anni, ed è passato il tempo di maritarmi.
- No, che non è questo il motivo per cui non volete dirmi di sì! - ripeteva compar Alfio col viso basso come lei. - Il motivo non
volete dirmelo! - E così rimanevano in silenzio a sminuzzare sterpolini senza guardarsi in faccia. Dopo egli si alzava per andarsene,
colle spalle grosse e il mento sul petto. Mena lo accompagnava cogli occhi finché poteva vederlo, e poi guardava al muro dirimpetto
e sospirava.
Come aveva detto Alfio Mosca, Alessi s'era tolta in moglie la Nunziata, e aveva riscattata la casa del nespolo.
- Io non sono da maritare, - aveva tornato a dire la Mena; - maritati tu che sei da maritare ancora; - e cosi ella era salita
nella soffitta della casa del nespolo, come le casseruole vecchie, e s'era messo il cuore in pace, aspettando i figliuoli della
Nunziata per far la mamma. Ci avevano pure le galline nel pollaio, e il vitello nella stalla, e la legna e il mangime sotto la
tettoia, e le reti e ogni sorta di attrezzi appesi, il tutto come aveva detto padron 'Ntoni; e la Nunziata aveva ripiantato
nell'orto i broccoli ed i cavoli, con quelle braccia delicate che non si sapeva come ci fosse passata tanta tela da imbiancare,
e come avesse fatti quei marmocchi grassi e rossi che la Mena si portava in collo pel vicinato quasi li avesse messi al mondo
lei, quando faceva la mamma.
Compare Mosca scrollava il capo, mentre la vedeva passare, e si voltava dall'altra parte, colle spalle grosse. - A me non mi
avete creduto degno di quest'onore! - le disse alfine quando non ne poté più, col cuore più grosso delle spalle. - Io non ero
degno di sentirmi dir di sì!
- No, compar Alfio! - rispose Mena la quale si sentiva spuntare le lagrime. - Per quest'anima pura che tengo sulle braccia!
Non è per questo motivo. Ma io non son più da maritare.
- Perché non siete più da maritare, comare Mena?
- No! no! - ripeteva comare Mena, che quasi piangeva. - Non me lo fate dire, compare Alfio! Non mi fate parlare! Ora se io mi
maritassi, la gente tornerebbe a parlare di mia sorella Lia, giacchè nessuno oserebbe prendersela una Malavoglia, dopo quello
che è successo. Voi pel primo ve ne pentireste. Lasciatemi stare, che non sono da maritare, e mettetevi il cuore in pace.
- Avete ragione, comare Mena! - rispose compare Mosca; a questo non ci avevo mai pensato. Maledetta la sorte che ha fatto nascere
tanti guai!
Così compare Alfio si mise il cuore in pace, e Mena seguitò a portare in braccio i suoi nipoti quasi ci avesse il cuore in pace
anche lei, e a spazzare la soffitta, per quando fossero tornati gli altri, che c'erano nati anche loro, - come se fossero stati
in viaggio per tomare! - diceva Piedipapera.
Jacques Prevert
Le foglie morte (1945)
Oh, vorrei tanto che anche tu ricordassi
i giorni felici del nostro amore
Com’era più bella la vita
E com’era più bruciante il sole
Le foglie morte cadono a mucchi...
Vedi: non ho dimenticato
Le foglie morte cadono a mucchi
come i ricordi, e i rimpianti
e il vento del nord porta via tutto
nella più fredda notte che dimentica
Vedi: non ho dimenticato
la canzone che mi cantavi
E’ una canzone che ci somiglia
Tu che mi amavi
e io ti amavo
E vivevamo, noi due. Insieme
tu che mi amavi
io che ti amavo
Ma la vita separa chi si ama
piano piano
senza nessun rumore
e il mare cancella sulla sabbia
i passi degli amanti divisi.
Le foglie morte cadono a mucchi
e come i loro ricordi, i rimpianti
Ma il mio fedele e silenzioso amore
sorride ancora, dice grazie alla vita
Ti amavo tanto, eri così bella
Come potrei dimenticarti
Com’era più bella la vita
e com’era più bruciante il sole
Eri la mia più dolce amica.
Ma non ho ormai che rimpianti
E la canzone che tu cantavi
la sentirò per sempre
E’ una canzone che ci somiglia
Tu che mi amavi
e io ti amavo
E vivevamo, noi due, insieme
tu che mi amavi
io che ti amavo
Ma la vita separa chi si ama
piano piano
senza nessun rumore
e il mare cancella sulla sabbia
i passi degli amanti divisi.
Nazim Ikmet
Addio (1960)
L’uomo dice alla donna: ti amo
Come se stringessi tra le palme il mio cuore
Simile a scheggia di vetro che mi insanguina le dita,
quando lo spezzo follemente.
La donna dice all’uomo:
ho guardato nei tuoi occhi,
nel mio cuore,
con amore curvandomi sulle tue labbra.
L'uomo ha taciuto.
Un libro caduto sul pavimento.
Una finestra si è chiusa.
Come un mormorio nelle tenebre.
Italo Calvino
L’avventura di due sposi1976)
L’operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle sei. Per rincasare aveva un lungo tragitto, che
compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le
sette, cioè alle volte un po’ prima alle volte un po’ dopo che suonasse la sveglia della moglie, Elide.
Spesso i due rumori: il suono della sveglia e il passo di lui che entrava si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola
in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso
affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli
sugli occhi. Gli appariva così , in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé
sul lavoro: il portavivande, il termos, e li posava sull’acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena
lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si
vergognasse un po’ di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la
faccia mezz’addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un’altra cosa, ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi
dallo stesso sonno, si è pari.
Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla, con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse;
allora tutto era più naturale, la smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra, le braccia che s’alzavano
per stirarsi, nude, finivano per cingere il collo di lui. S’abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile; a
sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva: se pioveva o faceva nebbia o c’era neve, a secondo di com’era umido e freddo.
Ma gli diceva lo stesso: Che tempo fa? e lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli
inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine: il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso
da quello di quando c’era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto, e così via.
A quell’ora, la casa era sempre poco scaldata, ma Elide s’era tutta spogliata, un po’ rabbrividendo, e si lavava, nello stanzino
da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente, si toglieva di dosso la polvere
e l’unto dell’officina. Così stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po’ intirizziti, ogni tanto dandosi
delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio, e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il
momento della confidenza, e alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, s’insinuava una carezza, e si
trovavano abbracciati.
Ma tutt’a un tratto Elide: Dio! Che ora è già! e correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta, in piedi, e con
la spazzola già andava su e giù per i capelli, e sporgeva il viso allo specchio del comò , con le mollette strette tra le labbra.
Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta, e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po’
impacciato, di dover stare lì senza poter fare nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un
bacio, apriva la porta e già la si sentiva correre giù per le scale.
Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini, e quando non la sentiva più continuava a
seguirla col pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram.
Il tram lo sentiva bene, invece: stridere, fermarsi, e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l’ha preso,
pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d’operai e operaie sull’ undici , che la portava in fabbrica
come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto.
Il letto era come l’aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, come fosse stato rifatto
allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una gamba in là, dov’era rimasto il calore di sua
moglie, poi ci allungava anche l’altra gamba, e così a poco a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia
di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s’addormentava.
Quando Elide tornava, alla sera, Arturo già da un po’ girava per le stanze: aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere.
Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po’, anche mettere a bagno la roba
da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui a dir la verità non ci metteva nessun impegno in più: quello che lui faceva
era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori
s’accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell’animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante
donne che fanno la spesa alla sera.
Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina,
adesso appesantito, perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo,
le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina, senza togliersi il cappotto, intanto
che lui levava la roba dalla sporta. Poi: Su, diamoci un addrizzo, lei diceva, e s’alzava, si toglieva il cappotto, si metteva
in veste da casa. Cominciavano a preparare da mangiare: cena per tutt’e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per
l’intervallo dell’una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l’indomani, e quella da lasciare pronta per
quando lui l’indomani si sarebbe svegliato.
Lei un po’ sfaccendava un po’ si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l’ora in cui
era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po’ distratto, con la testa già ad altro. In quei
momenti lì , alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più
attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le
desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa,
fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare.
Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c’era il momento dello
struggimento che li pigliava tutti e due d’avere così poco tempo per stare insieme, e quasi non riuscivano a portarsi il
cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano.
Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine.
S’abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com’era morbida e tiepida la sua sposa. Ma si caricava sulla spalla
la canna della bici e scendeva attento le scale.
Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui
correva le strade buie, tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla
propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito, per cercare il calore di lui, ma ogni volta
s’accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza.
Davide Carboni
in Avanguardia n. 30 anno X, 2005
Monica
Correva l’anno 1914, Monica e Piero erano uniti da un meraviglioso rapporto di profondo amore,che aveva conosciuto la sua apoteosi
con il loro matrimonio nel 1911. A Napoli regnava una società patriarcale nella quale l’opinione delle donne era insignificante,
sia all’interno della famiglia sia in ambito pubblico: erano costrette in casa dai mariti a pulire, cucinare, lavare, stirare,
insomma, “sgobbare” per il benessere della famiglia.
Ma Piero non era così, lui era diverso; amava Monica e non avrebbe potuto mai usarla per il proprio benessere, o farle del male
fisico o psicologico.
Vivevano della modesta attività della macelleria di Piero e riuscivano anche a risparmiare qualcosa per il futuro.
I due consorti avevano già programmato di dare alla luce un figlio quando, nel 1915, l’Italia entrò in guerra e Piero fu chiamato
alle armi, lasciando Monica in balia della spietata società napoletana. Si lasciarono con la promessa che sarebbero sopravvissuti
entrambi, per ricongiungersi alla fine della guerra.
Come Piero, anche Monica aveva la sua guerra da combattere: quella contro la discriminazione.
Quando lo Stato le confiscò la macelleria per cause ignote, Monica cercò in tutta la città un impiego che potesse garantire la
sopravvivenza a lei ed al bambino, che cresceva nel suo grembo; ma tutti i lavori che le vennero offerti erano troppo pesanti
per una donna incinta, o le porte delle aziende le venivano chiuse in faccia, non appena i direttori si accorgevano del
rigonfiamento del suo grembo.
Non esistevano leggi che tutelassero la maternità.
Viveva ormai di stenti quando decise di dar fondo a tutti i suoi risparmi per acquistare una piccola proprietà fuori città, nella
quale fece fiorire una modesta fattoria, in cui il bimbo cresceva sano. Piero non riuscì a mantenere la promessa fatta a Monica:
morì nel 1917, mentre tornava a casa, il camion, che finalmente riconduceva alle proprie famiglie i pochi soldati sopravvissuti,
finì su di una mina inesplosa, e per tutti i militari ci fu una tragica fine ingloriosa.
Monica riuscì comunque a sopravvivere con 1a speranza di rivederlo un giorno, senza mai voler accettare la realtà, cioè la sua
morte, che un freddo dispaccio le aveva annunciato. Ebbe una vita molto lunga; il figlio Esposito le diede tre nipotini.
Morì nel 1977, all’onorevole età di ottantasette anni, lasciando a Esposito una delle più grandi aziende specializzate nel
commercio di latticini.
Cibo: norme ed eccessi
Indice
- N. Gori: Il digiuno e le religioni
- L. Fornari: I disturbi alimentari
- Le superstizioni alimentari italiane
- Gravidanza
- Corteggiamento
- Nozze
- Riti funebri
- Riti invernali
- Natale
- Capodanno
- Epifania
- Carnevale
- Quaresima
- Pasqua
- Tutti santi
- Antico galateo
- Acqua
- Cipolla
- Digiuno
- Latte
- Mandorla - nocciola
- Pane
- Sale
- Uovo
- E. Bianchi: Non so amare dunque mangio
Nicola Gori
A colloquio con padre Theodoro Mascarenhas, officiale del Pontificio Consiglio della Cultura.
Il digiuno e le religioni
Strumento di autocontrollo, precetto dottrinale, metodo di ascesi, richiamo alla sobrietà, veicolo di elevazione al trascendente: nel corso dei secoli tutte le grandi religioni del mondo hanno dedicato particolare attenzione al rapporto dell'uomo con il suo corpo, in particolare alla pratica del digiuno. L'astensione dal cibo assume di volta in volta significati diversi. Con padre Theodoro Mascarenhas, officiale del Pontificio Consiglio della Cultura e docente di teologia biblica all'Angelicum, abbiamo parlato della tradizione del digiuno nell'islam e in alcune religioni orientali.
La pratica del digiuno nell'islam sembra sostenere tutta l'impalcatura religiosa. Ma qual è il fine ultimo del digiuno per gli islamici?
Per i musulmani il motivo del digiuno è l'autocontrollo. Secondo questa religione monoteista, quando una persona è vinta dai desideri e dalle brame materiali, diventa negligente riguardo al proprio essere spirituale e indifferente agli obblighi imposti dal Creatore. Perciò, per aiutare l'uomo a combattere queste bramosie materiali, l'Onnipotente ha imposto il digiuno come obbligo. Il digiuno durante il mese del ramadan non è per un'espiazione o un pentimento. Non è neppure una specie di castigo; è, invece, un rito religioso caratterizzato da un proposito positivo. Questo è spiegato bene nel Corano: "O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto. Forse diverrete timorati" (Surat ul-Baqarah, 2: 183). Il digiuno, dunque, ha un significato spirituale e sociale. I musulmani credono che, attraverso il digiuno, l'anima dell'uomo viene liberata dalle catene delle sue voglie e vola verso l'Altissimo. Il digiuno chiude le porte alle tentazioni. Come il diavolo attacca l'uomo, più spesso sulla debolezza della lingua e del corpo, così l'astensione dal cibo e dal sesso blocca queste aggressioni. Il digiuno fa diventare la persona timorata di Dio. Per questo motivo, ogni adulto deve praticarlo, insieme all'obbligo di leggere una parte del Corano ogni giorno del periodo di digiuno e di partecipare al culto comunitario. Inoltre, c'è la dimensione sociale. Con il digiuno la persona può avere una conoscenza migliore dei doni di Dio ricevuti e, così, aprirsi con più compassione e carità verso i disagiati e gli emarginati. Il digiuno include l'astensione, dall'alba al tramonto, da tutti i piaceri carnali come, ad esempio, il cibo e il sesso.
Tra le religioni orientali forse quella buddista è la più conosciuta nel mondo occidentale. Ci può spiegare qual è la filosofia che sottende all'idea del digiuno in questa religione?
È vero che le religioni orientali dedicano una attenzione particolare al rapporto con il corpo. Il digiuno è un modo per esercitare
il controllo sul proprio corpo. Nel buddismo, il digiuno è un mezzo per ottenere un livello più alto di spiritualità, cioè
svegliarsi
, una fase iniziale di autodisciplina. Per Buddha, il Nirvana è uno stato di pace perfetta della mente, libera dal
desiderio, dalla rabbia e da altre condizioni che la imprigionano. Il desiderio, secondo Buddha, era la causa e la radice del male.
Il cibo è il desiderio più basilare dell'uomo. Quindi è necessario rinunciare al desiderio per ottenere la libertà dai grovigli
mondani. Il digiuno è uno dei dhutanga che i monaci praticano per "scuotersi" o per "rinvigorirsi". Buddha stesso aveva digiunato
prima di essere "illuminato". L'illuminazione spirituale di Buddha è strettamente legata al digiuno, ma egli vi è arrivato non
durante il digiuno ma subito dopo, cioè dopo averlo interrotto. Così si arriva alla conclusione che non è il cibo, né
l'astensione da esso che porta alla "liberazione", ma la moderazione. Allora, il digiuno è un esercizio pratico per
andare verso il Nirvana.
È tanto diversa la prassi del digiuno nell'induismo?
Qualcosa in comune ce l'hanno, anche se le differenze sono a volte sostanziali. Gli indù sono profondamente religiosi. L'obiettivo della vita è l'autorealizzazione o il raggiungimento della consapevolezza dell'assoluto. Il digiuno controlla la passione e argina le emozioni e i sensi. Come l'oro è purificato dal fuoco, così la mente viene lentamente purificata dal digiuno ripetuto. Secondo le scritture indù, il digiuno è un grande strumento di autodisciplina che stabilisce un rapporto armonioso tra il corpo e l'anima, portando l'uomo ad accordarsi con l'assoluto. La parola sanskrita upvas, digiuno, che significa letteralmente sedere vicino (a Dio), già indica questo movimento di unione con l'assoluto. Il digiuno, quindi, è una negazione delle necessità del corpo per un guadagno spirituale. Secondo la filosofia indù, il cibo significa gratificazione del corpo e, invece, affamare i sensi vuol dire elevarli alla contemplazione. Attraverso il controllo del corpo fisico, delle emozioni e della mente, si può arrivare all'obiettivo finale della conoscenza incondizionata, o liberazione dal ciclo della rinascita, in unione con il trascendente sia personale, sia impersonale. Inoltre, nell'induismo, una persona può digiunare per adempiere un voto religioso, vrata. In questo senso, il digiuno e l'astinenza portano al raggiungimento del merito religioso, il quale può poi essere usato per ottenere l'obiettivo per cui si era fatto il voto.
Si coglie qualcosa di comune, dunque, in questo percorso spirituale che attraversa il digiuno in queste tre religioni. Di cosa si tratta?
Certamente i percorsi spirituali di queste tre religioni hanno alcune cose in comune. Tutte le religioni incoraggiano a usare il digiuno come forma di disciplina e di purificazione della persona. In tutte e tre esiste la motivazione dell'autocontrollo e dell'autodisciplina. Inoltre, si vede che un pensiero fondamentale di tutte le culture e di tutte le religioni del mondo è che "l'uomo non vive solo di pane" ma c'è qualcosa che trascende il mondo materiale. Il digiuno, cioè l'astensione dall'alimentare le forze del corpo, porta l'uomo alla conoscenza di un potere superiore, prima di tutto dentro se stesso, che, nel caso dell'islam e dell'induismo porta ad una conoscenza dell'Essere assoluto.
In cosa si differenzia la pratica del digiuno di queste religioni da quella cristiana?
È difficile indicare una differenza generale. Si può fare una distinzione tra la pratica cristiana del digiuno rispetto alle altre religioni. Ad esempio: se nel buddismo il digiuno è quasi fine a se stesso - ricordiamo che il buddismo è una religione di matrice ateistica - per i cristiani rappresenta un mezzo per vivere con Dio. Per citare le parole di Benedetto XVI nel suo messaggio per la quaresima, il digiuno serve per "aiutarci a mortificare il nostro egoismo e ad aprire il cuore all'amore di Dio e del prossimo, primo e sommo comandamento della nuova legge e compendio di tutto il Vangelo". La differenza tra la pratica cristiana e quella induista del digiuno si distingue per il fatto che l'induismo è una religione politeista, dove ognuno fa il voto secondo i suoi bisogni e secondo il proprio modo di concepire la divinità. Infatti, nell'induismo il digiuno è individuale e volontario, mentre nel cristianesimo, come nell'islam, il digiuno è obbligatorio almeno nei giorni prescritti. Inoltre, nell'induismo lo sforzo mira a liberare la mente e a rompere il ciclo della rinascita; invece nella pratica cristiana - come afferma il Papa nel suo messaggio quaresimale - "la fedele pratica del digiuno contribuisce inoltre a conferire unità alla persona, corpo ed anima, aiutandola ad evitare il peccato e a crescere nell'intimità con il Signore". La pratica nell'islam sembra avvicinarsi di più alla pratica del digiuno cristiano. Infatti, in entrambe il digiuno aiuta a liberare la persona per amare Dio e il prossimo. Tuttavia, mentre i musulmani digiunano durante il mese di ramadan dall'alba al tramonto e poi possono mangiare quanto vogliono, nella pratica cristiana non c'è questa distinzione netta tra il periodo di digiuno dal periodo in cui non è prescritta tale pratica. Ancora, nell'islam c'è, talvolta, una attenzione ai tempi, alle forme e alle norme, mentre nel cristianesimo si pone l'accento più sulla disposizione interiore. Il digiuno, nella religione cristiana, fa parte normalmente del tempo di quaresima, che viene indicato come un tempo di penitenza. Lo spirito di penitenza pervade tutto il periodo quaresimale e il digiuno è solo una delle forme di penitenza. Per citare ancora Benedetto XVI nel suo messaggio: "Usiamo in modo più sobrio parole, cibi, bevande, sonno e giochi, e rimaniamo con maggior attenzione vigilanti".
Che cosa possono imparare i cristiani dal modo di concepire il digiuno dei fedeli di queste religioni?
La pratica del digiuno nelle tre religioni sulle quali ci siamo soffermati possono arricchire il nostro modo di concepire e di osservare il digiuno. Dal buddismo, in particolare dalla sua concezione della liberazione della mente attraverso il digiuno, possiamo imparare a rafforzare la nostra antica nozione del digiuno, come spiegato da Benedetto XVI nel suo messaggio, cioè che il digiuno sia "di grande aiuto per evitare il peccato e tutto ciò che ad esso induce". Dalla pratica nell'induismo impariamo che il digiuno può diventare una forma di preghiera, come afferma il Papa: il digiuno può "aprire nel cuore del credente la strada a Dio". Nella Chiesa cattolica il digiuno è una pratica regolata da norme minime e lasciata quasi interamente alla coscienza del credente. L'islam, invece, ha regole e leggi molto prescrittive e richiede la pratica rigorosa del digiuno da parte dei credenti. Forse un po' di questo rigore, senza esagerazioni, farebbe bene alla pratica cristiana. Questo potrebbe aiutare a recuperare l'indifferenza che, talvolta, si mostra verso la pratica del digiuno. Per i musulmani leggere il Corano e partecipare al culto, durante il periodo di digiuno, è obbligatorio. In questo senso, noi cristiani accogliamo l'appello del Pontefice "ad un maggior impegno nella preghiera, nella lectio divina, nel ricorso al sacramento della riconciliazione e nell'attiva partecipazione all'Eucaristia, soprattutto alla messa domenicale".
L'Osservatore Romano 6 marzo 2009
I disturbi alimentari
di Laura Fornari
Con il termine disturbo alimentare si indica una vera e propria malattia, la prima causa di morte fra le malattie psichiatriche, e si riscontra sempre più frequentemente in ragazze giovani, ma anche in soggetti di trenta, trentacinque anni. E’ un "male di vivere" che forse nasce da un rapporto distorto con la famiglia e con gli altri, ma prima di tutto con sé stessi, con la propria individualità.
Questa malattia ha una lunga storia, ma la sua esplosione è avvenuta particolarmente dopo la seconda guerra mondiale e in prevalenza nei paesi industrializzati. Sia l’anoressia che la bulimia, sono praticamente sconosciute al di fuori del mondo occidentale. Alla fine degli anni Sessanta le patologie alimentari hanno subito un impressionante aumento, dovuto al fatto che questi disturbi costituiscono l’espressione estrema del cambiamento delle aspettative sociali nei confronti delle donne.
Quasi sempre inizia con una dieta, ma alla base ci sono molte altre cause scatenanti che portano queste ragazze a cercare l’illusione di poter spostare sul cibo il controllo che pensano di non avere sulla propria vita.
Allora cerchiamo di capire quali sono questi fattori scatenanti e di spiegare su quali basi si fondano e come mai si automantengono.
Ci sono delle difficoltà di relazione in famiglia e nei rapporti con gli altri che si accompagnano ad una insoddisfazione nei confronti del proprio aspetto e delle forme del proprio corpo.
Si decide di mettersi a dieta; all’inizio solo con l’intenzione di modificare il proprio corpo, ma in seguito questo comportamento rinforza il senso di autocontrollo e di conseguenza la sensazione del proprio valore (io sono più brava di altri nel fare questa cosa perciò valgo di più). In questa fase hanno un grosso peso i rinforzi sociali!
Le amiche le invidiano perché riescono a stare a dieta e a dimagrire, le persone in genere fanno loro complimenti per la loro forma fisica. Per i primi giorni digiunare è faticoso ma i risultati le compensano della fatica, anzi rinforzano la loro autostima.
Purtroppo, quando le diete sono troppo drastiche, portano il corpo ad avere comportamenti biologici funzionali alla sopravvivenza; viene così prodotta una quantità di serotonina (neurotrasmettitore che seda la sofferenza e il dolore) molto superiore alla norma e così, per i primi tempi, queste ragazze sentono di avere una forza e delle capacità superiori alla norma. Questo periodo, che è quello più critico per l’instaurarsi della malattia, viene definito luna di miele con l’anoressia. A questo punto si instaura un meccanismo che è quello che rende così difficile la cura di questa malattia: la sensazione che provano queste ragazze di aver trovato la cura per i propri problemi. Così come l’alcolista considera l’alcol il sostegno di cui ha bisogno per affrontare delle situazioni in cui si sente inadeguato e poi cade in una dipendenza invalidante.
Con il protrarsi della dieta, che diventa sempre più restrittiva, anche questo vantaggio iniziale viene a mancare ed inizia la fase della depressione, della fobia per il cibo, della percezione errata della propria immagine corporea, la scomparsa del ciclo mestruale.
Molte ragazze ed anche adulti, per motivi diversi, devono osservare una dieta dimagrante, ma non per questo sviluppano questa
malattia. Questa è la perplessità di molte persone. In effetti ci si è molto interrogati su questo punto e tuttora gli studi
sono in corso, sia a livello biologico che psichico. Una cosa che si ritrova sempre in questi casi è la presenza di un fattore
precipitante che scatena il disturbo. Possono esserci tutti i fattori che predispongono a sviluppare la malattia, ma non si
sviluppa perché manca il fattore precipitante. Una ragazza che soffre di questo disturbo l’ha definito
la goccia che fa traboccare il vaso
. Quella goccia dà inizio all’insoddisfazione corporea. L’insoddisfazione per il proprio
peso, per l’aspetto fisico, porta a fare una dieta. Come già detto, la cosa particolare è che in questi casi la dieta è severa e
viene utilizzata per aumentare la propria autostima, ci si gioca il senso di autocontrollo ed il proprio valore personale;
questa è la differenza rispetto al semplice perdere qualche chilo.
Anche il clima culturale in cui oggi le ragazze crescono, ha un peso fondamentale nell’instaurarsi di questa malattia. La dove il ruolo femminile viene vissuto con confusione, è più difficile per una donna sviluppare un’identità femminile chiaramente definita ed armonizzare le aspettative e le esigenze personali con quelle del mondo esterno. Il fatto che questo disturbo si sia diffuso in forma epidemica negli Stati Uniti, ci riporta alle richieste sociali di quella cultura rispetto al ruolo femminile: il modello della donna di successo, competitiva e autonoma. A questo tipo di donna moderna, vengono associati la magrezza, la forma fisica e l’autocontrollo.
La bulimia, pur avendo alla base gli stessi valori culturali che stanno alla base dell’anoressia, ha alla base anche una difficoltà molto evidente di autonomizzazione dalla propria famiglia d’origine, oppure si instaura dopo l’anoressia, la dove c’è un carattere più impulsivo e meno volitivo. Allora si cede alla "tentazione" del cibo abbuffandosi in modo compulsivo ed ossessivo, poi si ricorre al vomito per rimediare. In questi casi i problemi fisici sono ancora più gravi che nell’anoressia, meno evidenti e più subdoli, come ci si accorge di queste malattie, dei segnali da non sottovalutare e perché è importante intervenire molto presto.
copyright © Educare.it - Anno I, Numero 11, Ottobre 2001
Le superstizioni alimentari italiane
Le superstizioni alimentari italiane è il frutto di una analisi storica e psicologica sulle superstizioni, le scaramanzie, i tabù e le credenze popolari connesse con il cibo e l'alimentazione, ideato e realizzato dal Dott. Matteo Mugnani.
Il Format di "Gastro-sofia: le superstizioni alimentari italiane" è stato ospitato all'interno della manifestazione internazionale della "VI° settimana della lingua italiana nel mondo" (del 2006, dedicata a "il cibo e le feste nella tradizione italiana"), organizzata dal Ministero degli Esteri in collaborazione con gli Istituti di Cultura Italiana delle Ambasciate Italiane, dove è stato presentato dal Dott. Matteo Mugnani, in forma di Conferenza-Spettacolo, nel teatro della Associazione Dante Alighieri presso la Casa D'Italia di Maracay (Venezuela).
Ogni giorno usiamo proverbi, superstizioni, scaramanzie, tabù, di cui però non conosciamo il significato, né l'origine. Facciamo cose, per scaramanzia, senza sapere perché le facciamo; la nostra cultura ha dimenticato di spiegarci il perché delle cose che facciamo; celebriamo feste e riti senza comprendere il senso. E quando non si sa più perché si fa qualcosa, o perché si ritiene che una cosa porti sfortuna o fortuna, significa che si è rimasti culturalmente soli, senza più un dialogo aperto e reciproco con le nostre origini culturali.
Vi sono molte versioni, non contrastanti tra loro, sull'origine del concetto di superstizione: la più condivisa, proposta già da Lattazio, è che si tratti di qualcosa di "superstite", un avanzo delle antiche tradizioni pagane; mentre Cicerone riteneva che derivassero da "superstites" (superstiti), cioè invocazioni agli Dei affinché risparmiassero i figli dalle loro ire funeste; in modo simile S. Agostino le faceva risalire al verbo arcaico "superstito", cioè preservare, far durare, sopravvivere. E' evidente dunque la comune origine di scongiurare una morte (propria o altrui), come già accadeva in tutti gli antichi riti pagani della tradizione pre-cristiana.
Oggi in pochi saprebbero dire perché il numero 17, essere in 13 a tavola, il colore viola o il fatto di passare sotto una scala sono ritenuti portatori di sfortuna, eppure quasi tutti, se possono, li evitano automaticamente o almeno li esorcizzano con qualche gesto scaramantico, come il fatto di toccare ferro, legno, o determinate parti del corpo. Ma anche in questo caso pochi sanno perché quei gesti avrebbero un effetto protettivo contro la sfortuna. Anche il cibo e l'alimentazione, come era prevedibile, visto che nel passato i periodi di carestia erano frequenti e mietevano moltissimi morti, sono stati oggetto di innumerevoli riti scaramantici, superstizioni e tabù. Vediamo di esaminarli e comprenderne l'origine e il significato.
Il numero 17 è ritenuto sfortunato per due ragioni, la prima è che la tradizione vuole che il giorno della crocifissione di Gesù Cristo, fosse caduto nel giorno 17, la seconda è che in numeri romani, il 17 era scritto XVII, che anagrammato compone la parola VIXI, che in latino significa "vissi", ovvero "non vivo più, sono morto". Il colore viola è detestato originariamente solo dagli artisti, perché nel medioevo, durante la pasqua (il cui colore religioso è il viola), venivano apposti dei drappi di colore viola sulle finestre delle chiese, e in quei giorni venivano vietate tutte le forme di rappresentazioni teatrali pubbliche nelle piazze e nelle strade delle città, per rispetto della passione di Gesù, così che gli artisti di strada, non lavorando, facevano la fame. Anche essere 13 a tavola riguarda Gesù, perché durante l'ultima cena a tavola erano appunto in 13, e poco dopo Gesù fu tradito e ucciso.
Essere in 13 a tavola dunque, è considerato da allora un presagio di tradimento e di morte. Per quanto riguarda il fatto di passare sotto una scala, questo è dovuto al fatto che una scala appoggiata a un muro forma un triangolo (muro, pavimento, scala inclinata), ed il triangolo è il simbolo di Dio, e dunque passare dentro al triangolo porterebbe sfortuna perché significherebbe voler accedere alla condizione divina ed entrare nello spazio di Dio. E' evidente, dunque, come ogni scaramanzia non è altro che un retaggio di antiche credenze popolari, spessissimo di derivazione religiosa, che sono però fondate su un senso logico e spiegabile. Ad ulteriore dimostrazione della natura antica delle scaramanzie, anticiperò il fatto che su un cibo "recente" come il pomodoro, che è stato importato dall'America solo dopo il viaggio di Cristoforo Colombo (prima del 1492 in Europa non esisteva), non esiste nessuna superstizione, come invece ne esistono da sempre su quasi tutti gli altri cibi (aglio, uova, cipolla, uva, lenticchie…).
La cultura che più ci ha tramandato e spiegato le superstizioni e le scaramanzie alimentari, è quella della tradizione contadina italiana, che essendo fortemente basata sulla produzione agricola e sull'allevamento, e non avendo avuto occasione di dedicarsi a studi culturali, è stato l'humus ideale affinché si tramandassero di generazione in generazione le credenze popolari connesse con gli spettri della carestia e della morte, e i riti per esorcizzarli. Questa analisi storica ci mostrerà inoltre come il cibo è stato, già nella tradizione contadina, uno status-symbol importante, tanto che i testi storici ci riportano come anche solo a metà del secolo scorso, la domenica mattina, in occasione delle feste locali, le famiglie contadine ponevano gusci d'uovo, ossa e altri avanzi sulla finestra delle case, come ostentazione di una ipotetica cena abbondante che testimoniasse la salute e la ricchezza della famiglia che la abitava; in verità si trattava degli stessi avanzi di cibo, messi da parte per molti mesi, che ogni domenica facevano avanti e indietro sul davanzale della finestra, per costruire un'immagine solo apparente, destinata ai vicini di casa. Nell'approcciarci a questa ricostruzione storica e psicologica del rapporto tra il cibo, le scaramanzie e le superstizioni, procediamo dividendo i riti previsti, nella tradizione contadina italiana, in occasione degli eventi principali della vita (gravidanza, matrimonio, funerali, Natale, Capodanno, Pasqua, ecc).
GRAVIDANZA
Appena nasceva un bambino, in nome delle superstizioni, e quindi per proteggerlo idealmente dal rischio della mortalità infantile (che un tempo era molto frequente) gliene venivano fatte letteralmente di tutti i colori. Appena nato gli veniva messo in bocca qualche cristallo di sale grosso, nella convinzione che il sale allontana il maligno (perché tradizione vuole che le streghe non potessero usarlo nelle loro pozioni e dovessero mangiare insipido), poi veniva preso dal padre e passato per tre volte sul fuoco acceso del caminetto, affinché il fuoco lo proteggesse dalle future malattie, e quindi veniva messa la fuliggine dello stesso caminetto sotto la sua culla e sotto il suo cuscino, affinché la cenere (come con l'incenso delle benedizioni religiose) lo consacrasse. E se il bambino si ammalava nei primi mesi di vita, il rito veniva ripetuto, usando però il forno al posto del caminetto: veniva inserito tre volte nel forno acceso, appoggiato sulla pala del pane. Il padre poi, sempre poco dopo la nascita, uccideva una rondine e gli estraeva il cuore che faceva succhiare al bambino, affinché questo uccello libero, abituato a lasciare il nido e a volare presto, trasmettesse questi stessi valori al neonato.
Lo stesso avveniva anche con il cuore del maiale o del bue e con i testicoli del gallo, per trasmettergli forza ed essere prolifico. Tutto ciò ovviamente, in nome delle concezioni animistiche secondo cui si interiorizzerebbero le caratteristiche dell'animale mangiato. Inoltre attraverso il cibo desiderato durante le "voglie" delle donne in cinta si sarebbe capito in anticipo il colore dei capelli nel nascituro; se la voglia era di vino rosso, sarebbe stato moro, se era di vino bianco, sarebbe nato biondo. Mentre se la madre non aveva latte per allattare (il che era considerato un intervento del maligno, prima che si scoprissero gli ormoni), allora era lei che doveva mettersi del sale sul petto, come anti-maleficio, e doveva osservare il divieto assoluto di bere nel bicchiere altrui e magiare nel piatto altrui, perché si riteneva che l'invidia delle altre donne, trasmessa attraverso la saliva, gli potesse prosciugare il latte. Solo in ultima battuta veniva consigliato ciò che anche la scienza moderna confermerebbe, cioè di nutrirsi di brodo, uova, latte, vino, pasta, fagioli, a conferma che la medicina ancora veniva solo dopo la scaramanzia, cioè che la convinzione che il demonio ci mettesse lo zampino prevaricava le già note cognizioni scientifiche e igienico-sanitarie. Anche la condizione della donna ci viene spiegata attraverso le superstizioni: una donna che aveva appena partorito, era considerata impura e per questo non doveva assolutamente cucinare, e doveva mangiare in disparte e non a tavola, non poteva cambiarsi d'abito, né pettinarsi, né avere rapporti sessuali, né partecipare al battesimo del figlio. Doveva essere addirittura portata in chiesa e benedetta per ri-purificarla e riaccettarla in famiglia. Questo non si basa più di tanto su motivi igienici, quanto piuttosto su un pretesto per sottolineare una volta di più il ruolo ancora marginale delle donne. Interessante anche il rito dell'IMPAIOLATA, cioè "ins la paia" (sulla paglia), una festa in cui la madre del nascituro doveva sedere su una sedia fatta di paglia (originariamente direttamente su un covone di paglia). Era in pratica un pranzo successivo al battesimo del neonato, in cui i parenti e vicini portano cibi in dono: capponi, uova, formaggi, vino, dolci, i più poveri portano del pane. Si mangiavano per tradizione delle minestre e dolci a base di uovo (simbolo di nascita e di trionfo sulla morte). Inoltre il "galateo" dell'epoca prevedeva che i regali fossero più ricchi per i figli maschi e minori per le femmine (4 capponi se maschio, 2 se femmina).
CORTEGGIAMENTO
Molti dei riti del corteggiamento, non diversamente da oggi, erano connessi al cibo, anche allora il galateo prevedeva di pagare da bere alla ragazza, ma siccome questa non era ancora libera di uscire da sola, l'invito era esteso anche a tutta la sua famiglia, con un dispendio economico importante, che si protraeva praticamente fino alle nozze, visto che, pur in cambio della dote della fanciulla (e della sua mano...), il fidanzato doveva ottemperare ad una lunga e costosa sequenza di doni alimentari. Dal rito della Ligazza (con cui si ufficializzava il fidanzamento, passando dalla condizione di "filarino", cioè corteggiatore, a quella di "moroso"), fino alle nozze, il fidanzato doveva portare a casa di lei un numero sempre crescente di cesti di frutta fresca, frutta secca, caramelle, ciambelle, e durante la quaresima in particolare, le deve donare: 2 ciambelle la prima settimana, 4 la seconda, 6 la terza, 8 la quarta, 10 la quinta, 12 la sesta. In pratica una figlia che andava sposa era una bella notizia per tutta la famiglia. Anche il nuovo legame parentale tra le due famiglie era sancito da un pranzo, ma qui subentrava il vino, simbolo, fin dai tempi di Gesù, di un legame sacro: il rito del vino prevedeva che i genitori degli sposi bevessero dallo stesso bicchiere, per sancire la nuova parentela che andava formandosi.
NOZZE
L'arrivo delle nozze comportava una serie di pranzi ben più numerosi e ricchi di quelli odierni. La sequenza di pranzi nuziali (tutte a casa tranne una, all'osteria, con il fidanzato che invitava la fidanzata e le due rispettive madri), prevedeva infatti ben due diversi banchetti di nozze, il primo a casa della sposa (nel paese della sposa), e il secondo, la sera dello stesso giorno, a casa dello sposo. Il famoso riso che si lancia all'uscita dalla chiesa, ha ovviamente, anch'esso un significato e una storia precisa. Un tempo innanzitutto non si lanciavano chicchi di riso (introdotti solo in tempi moderni), bensì nocciole, perché la nocciola era il simbolo di fecondità per eccellenza, e venivano così regalati agli sposi; il fatto di lanciare il cibo (nocciole o riso che sia) offre un simbolo di ricchezza e di abbondanza (solo chi ha tanto cibo può permettersi di gettarlo via), ma ha anche un altro significato più importante, il lancio del seme (nocciola, riso) è il gesto che il contadino fa quando getta un seme nel suo campo, affinché possa germogliare e riprodursi. Al di là del riso, c'è da dire che i menù nuziali puntavano sulla quantità di cibo a discapito della qualità, per dare un'idea di opulenza beneaugurante, e i cibi immancabili erano, almeno nella tradizione emiliano-romagnola, i cappelletti, gli arrosti e tanti dolci. In altre zone geografiche ovviamente troviamo altri cibi, ma più o meno accomunati da significati simbolici simili. Prima del secondo banchetto, a casa dello sposo, il neo-suocero accoglieva la nuora fuori dalla casa, con un bicchiere di vino, simbolo della nuova parentela, mentre la madre dello sposo la accoglie sulle scale cedendole il mestolo da cucina, simbolo del cedere la funzione materna e di accudimento della casa e del figlio. Inoltre, durante questo secondo banchetto si versava per terra del vino, e come un oracolo si riteneva che la direzione del rivolo di vino pronosticasse il sesso del figlio; se andava verso nord sarebbe nato maschio, al contrario se andava verso sud sarebbe stata una femmina. Un'altra superstizione vuole che la seggiola destinata alla sposa in questo secondo pranzo di nozze, dovesse essere in realtà un sacco di farina, per augurare fertilità ai campi da coltivare. Una nota di colore riporta che le posate, i piatti e le stoviglie, che sarebbero state troppo numerose per una sola famiglia, venissero prese a prestito per i banchetti di nozze, dai contadini vicini.
RITI FUNEBRI
Il cibo più strettamente correlato alla morte è il pane, che, in quanto simbolo della vita, è sempre stato usato come amuleto contro la morte. Un’ antichissima superstizione imponeva che in casa non mancasse mai, anche di notte, per la sua funzione di talismano contro le forse maligne e la sfortuna, ma sopratutto per averlo a disposizione nel caso che qualcuno necessitasse improvvisamente di estrema unzione. L'usanza voleva altresì che la prima cosa che si faceva dopo la morte di qualcuno era di mettersi a fare il pane, sia come "dazio" per l'aldilà, che accompagni il defunto nel suo viaggi finale (già gli antichi egiziani ponevano nelle tombe, accanto alle mummie, del cibo), sia come rito di protezione per i parenti, però a prepararlo e a cuocerlo non dovevano essere i parenti del defunto, considerati impuri in quanto contaminati dalla morte che ha colpito la loro famiglia, ma altri vicini di casa o amici. Le cronache antiche riportano qualcosa che oggi ci è difficile immaginare, e cioè che durante la veglia funebre venivano organizzati giochi, banchetti con tantissimo cibo, balli rituali, a volte perfino riti sessuali orgiastici (di origine pagana), cioè tutta una serie di comportamenti allegri mirati ad esorcizzare la morte e riaffermare la continuità della vita. Il pranzo funebre, consumato in presenza del defunto, per il quale si apparecchiava anche un posto a tavola e a cui si servivano le pietanze come se fosse vivo, era composto rigorosamente da maltagliati o manfregoli (a forma di semi, come simbolo di rinascita), e le fave (poi denominate "fave dei morti"), era un'occasione per festeggiare l'unione dei sopravvissuti alla morte. Alla fine del pasto il cibo destinato al defunto veniva donato al becchino o gettato dalla finestra insieme alle sue stoviglie. A proposito di fave, la loro storia di cibo di morti è molto antica: gli antichi egizi pensavano che contenessero le anime dei morti (forse perché sono mature nel mese dei morti), e gli egizi non potevano né guardale né toccarle, proprio come forma di rispetto per le anime dei loro defunti.
Riti invernali (natale, capodanno, epifania).
Le 12 notti che separano il giorno di Natale dalla festa dell'Epifania, nell'antichità (ben prima dell'avvento del cristianesimo)
erano denominate "dodekameron", cioè 12 giorni necessari a far coincidere il calendario solare con quello lunare. Erano considerati
dei giorni fuori dal tempo normale, perché non appartengono né al vecchio anno, né al nuovo, bensì ad un tempo magico svincolato
dalle regole normali e morali, durante i quali era permesso l'ingresso degli inferi (e quindi dei morti) nella quotidianità dei vivi.
Per questo è naturale che attirassero un'enormità di paure e dunque anche di superstizioni.
Va ricordato che tutte le feste natalizie esistevano già prima dell'avvento di Gesù, e corrispondevano alla festa pagana della
nascita del sole, che cadeva proprio il 25 dicembre, tanto che è oggi condiviso dagli storici che il cristianesimo, nell'istituire
le proprio festività, si è in sostanza sovrapposto alle date e alle feste pre-cristiane che già esistevano nella tradizione pagana,
aggiungendovi però significati diversi (pur senza abolire quelli precedenti): la festa pagana della nascita del sole dunque diventa
la festa cristiana della nascita di Gesù. Questa "cristianizzazione" di feste e riti precedenti è peraltro molto frequente.
NATALE
Un’antica nota storica ci insegna tanto per cominciare che i regali di Natale, un tempo non erano affatto un gesto spontaneo
o d'affetto, bensì erano delle tasse. Si chiamavano regalie: i contadini erano obbligati a donare il cibo da loro coltivato e
accolto al padrone del terreno, come fosse una specie di pagamento dell'affitto del terreno. Ma ci si approcciava alla fine
dell'anno solare e dunque bisognava rispettare la superstizione imitativa che voleva che quello che si faceva e che si
mangiava negli ultimi giorni dell'anno precedente, si sarebbe protratto durante tutti i giorni dell'anno seguente.
I cibi classici della festa di Natale sono naturalmente i cappelletti o tortellini, sui cui nomi e forme esistono molte
credenze. Il cappelletto deriverebbe dalla forma del cappello dei preti, noti per la loro ingordigia alimentare (da cui il
modo di dire "il boccone del prete"), mentre il tortellino da un lato sarebbe la ricostruzione morfologica dell'ombelico di
venere, dall'altro, proprio perché originano da un ombelico, starebbe a rappresentare il cordone ombelicale (di cui
l'ombelico è il segno) che lega l'uomo con la fertilità della terra. Tra le infinite superstizioni che ruotano attorno
ai tortellini citiamo quella secondo la quale, mentre i tortellini stavano bollendo nel brodo il giorno di Natale,
bisognava andare a potare l'uva che si sarebbe mangiato a capodanno come rito propiziatorio. Un'ultima nota davvero
interessante sulla tradizione gastronomica connessa al Natale nell'antichità ci riporta, dagli antichi manoscritti
della tradizione contadina, l'esistenza di un cosiddetto "pane di natale", che corrisponde in tutto e per tutto,
all'attuale panettone: la ricetta prevedeva l'uso di tutta una serie di cibi simbolici che rappresentassero la morte e
la rinascita: le uova, l'uva secca, le mandorle, la mela, il latte, la frutta candita. Oltre naturalmente ai leganti di base,
strutto, farina, zucchero. Quello che ci interessa non è comprendere quando o dove nasce la ricetta del famoso panettone,
ma evidenziare che la sua ricetta è fortemente simbolica e radicata, nella scelta degli ingredienti, al dualismo tra
morte e rinascita.
CAPODANNO
Anche il capodanno è la prosecuzione di una antichissima festa pagana, come testimonia la tradizione del brindisi, dove l'uva e il vino erano usati nei riti propiziatori per la nuova vendemmia. E lo stesso dicasi per la superstizione delle lenticchie, che se mangiate a capodanno porterebbero denari, e degli acini d'uva, in numero rigorosamente dispari, anch'essa connessa ai riti propiziatori per la vendemmia successiva. Altre superstizioni (ancora molto usate) imponevano che il primo a solcare la porta di una casa nell'anno nuovo dovesse essere per forza un uomo, come auspicio di fertilità e dunque futuri figli maschi, sempre molto valorizzati nella tradizione del proletariato contadino. Anche i rimedi per il giorno dopo il capodanno, e dunque per le sbronze alcoliche, erano interessanti: si spaziava dal mangiare 7 noccioli di pesca, al bere il sangue d'anguilla. La minestra per eccellenza del capodanno erano gli gnocchi (che venivano chiamati anche maccheroni), cioè la stessa pasta che si cucinava quando nasceva un figlio maschio, creando un'evidente analogia tra il nascituro e l'anno nuovo, che appunto nasceva.
EPIFANIA (solstizio d'inverno)
La festa dell'epifania (cioè della befana, ovvero della "donna più anziana"), deriva da un antico rito pagano in cui la
donna più anziana della famiglia o dell'intera comunità, la sera del 5 gennaio doveva preparare la cena, perché era la più
vicina ai defunti, numi protettori della casa che avrebbero portato doni. La "befana" era dunque un punto di raccordo tra i
vivi e i morti. In questa occasione i giovani fidanzati si dovevano donare reciprocamente delle castagne, come simbolo di
fertilità femminile e di virilità maschile, e già nell'antichità esisteva l'usanza del rito delle "pasquelle", poi
cristianizzato attraverso l'immagine dei Re Magi che portano i doni a Gesù: si trattava dell'usanza per cui i bambini
suonavano e cantavano strofe augurali alle porte delle case, per ricevere in cambio dei dolci o altri cibi.
Si vede dunque
l'analogia con il rito moderno della "calza" della befana che porta doni ai bambini, in forma di dolciumi. La quantità di
cibi che venivano consumati e donati durante tutto il periodo che va da Natale fino a Carnevale, era nell'antichità dovuto
al fatto che, col sopraggiungere dell'inverno durante il quale i contadini dovevano restare in casa in attesa di poter
tornare al lavoro nei campi in primavera, e con la necessità dunque di continuare ad alimentarsi in assenza di cibi freschi
provenienti dai raccolti e con un fabbisogno moltiplicato dal freddo, si procedeva all'uccisione degli animali da
allevamento, in particolare il maiale, che con la sua carne ricca di grassi e di proteine, garantiva una scorta di energie
per il periodo invernale.
Il maiale non a caso costituisce la base lipidica e proteica dei cibi tipicamente natalizi, che
sono tutti eredità della tradizione contadina (zampone, cotechino, cappello del prete, tortellini, ecc). Il maiale era un
animale talmente importante per la sussistenza di tutta la comunità che si celebrava anche una festa a lui dedicata,
denominata le "nozze del porco", festeggiata nel giorno del 17 gennaio, in occasione della festa di S. Antonio Abate
(infatti raffigurato nell'iconografia sacra insieme ad un maiale); festa che consisteva in una uccisione collettiva di
alcuni maiali allevati dall'intera comunità e poi suddivisi tra tutti. Il motivo dell'allevamento collettivo (cioè condiviso
tra varie famiglie) non era solo per garantire a tutte le famiglie di avere una forma di sussistenza alimentare, ma
soprattutto per suddividere il senso di colpa per l'uccisione di un animale che i popoli antichi consideravano al pari degli
attuali animali domestici.
CARNEVALE
La parola carnevale evidenzia fin dalla sua etimologia la sua origine alimentare: significa infatti "carnem - levare", cioè "prendere la carne", perché veniva subito dopo l'uccisione del maiale e degli altri animali, nel periodo dell'anno dedicato alla preparazioni degli insaccati di carne, e quindi nel momento dell'anno in cui la disponibilità di carni fresche era massima. Cadeva nel momento dell'antico "capodanno di primavera" pre-cristiano (perché un tempo i mesi di gennaio e febbraio non esistevano sul calendario). Questa grande disponibilità di carne faceva tendere a festeggiamenti orgiastici per ringraziare e santificare le divinità pagane che avevano protetto la comunità, che corrispondevano come ho già spiegato ai proprio defunti di famiglia. E' proprio da questo che derivano anche le famose "maschere di carnevale", che rappresentano il ritorno dei morti (dei defunti di famiglia che venivano a trovare i vivi, e che agivano come numi tutelari protettori della casa, dei campi coltivati e degli allevamenti). La superstizione entra nel rito del carnevale attraverso la storia delle numerosissime maschere del carnevale, ma anche attraverso i riti del martedì e del giovedì "grasso", originati dal fatto che l'antica superstizione imponeva, in quei due giorni, di mangiare 7 volte, per poter poi resistere al digiuno del successivo periodo di quaresima che introduceva alla Pasqua.
QUARESIMA
Durante il periodo di quaresima, votato al digiuno purificatore, un’ antica superstizione (fondata su una credenza popolare), voleva che alle ragazze che mangiavano solo insalata (in particolare il radicchio), sarebbe cresciuto il seno. Esiste dunque una curiosa e incomprensibile origine antica dello stretto rapporto tra la femminilità e il digiuno, in cui la finalità estetica sembra predominante sulla razionalità. Il valore del digiuno quaresimale sembra derivare da una necessità igienico-sanitaria, per purificare cioè il corpo dopo il periodo degli eccessi del carnevale e dell'inverno, in cui, come detto, l'abbondanza di carne e la necessità di proteggersi dal freddo e dalle malattie, spingeva all'iperconsumo di cibi grassi.
PASQUA
In origine, nell'antichità, ben prima dell'avvento di Gesù Cristo, nel periodo della Pasqua si festeggiava una festa pagana fondata sul mito agreste del Dio Attis, una divinità della vegetazione, che in quel periodo dell'anno veniva festeggiato come l'artefice del miracolo del risveglio della natura dopo la "morte" invernale. Il mito della resurrezione di Cristo dunque sembra aver saputo riattualizzare, umanizzandola, una precedente festività pagana dedicata alla primavera e alla resurrezione dei campi. Il cibo simbolo della pasqua sono le uova, ve venivano già usate nelle feste pagane, colorate di rosso, e delle quali già si bruciavano i gusci. Abitudine questa che deriva dal fatto che si temeva che le streghe potessero usare tali gusci per le loro ricette malefiche. Anche l'acqua di cottura delle uova andava sparsa nell'orto o buttata nelle siepi, per lo stesso motivo. Anche le ricette pasquali ruotano attorno al mito dell'uovo, simbolo per eccellenza della rinascita (dei campi prima, e di Gesù Cristo poi): dai passatelli (minestra a base d'uovo), ai dolci a forma di colomba, che è un altro tipico simbolo della primavera, a conferma dell'origine agreste pre-cristiana di questa festività.
TUTTI I SANTI e GIORNO DEI MORTI
Si tratta dell'antico capodanno celtico, il cosiddetto "simuin", da cui deriva la festa di Halloween festeggiata in Inghilterra e oggi esportata, in modo un po’ storpiato, in tutto il mondo. Siccome la antica festa pagana dei morti era ancora molto sentita dalle popolazioni, dal 2 novembre del 998 d.C., quindi circa un millennio fa, la Chiesa Cattolica dovette istituire questa festa, per integrarla tra i proprio riti, farla propria, e poter indirizzare il corso delle fobie collettive ed esorcizzarle.
Anche l'antico galateo della tavola rivela, ad un'analisi storica, delle sfaccettature inattese: ad esempio va ricordato che fino al '600 la mano sinistra era vietata a tavola, non la si poteva usare per nessun uso, tanto che la forchetta (che si maneggia appunto con la sinistra), venne introdotta solo nel '600. Questo perché la mano destra (ritenuto il lato di Dio), era destinata al cibo, mentre quella sinistra (ritenuto il lato del Diavolo), era riservata all'igiene intima. Un fatto importante, vista la assoluta scarsità d'igiene dei tempi antichi, che ci spiega dunque l'origine igienico-sanitaria di questa e di molte altre pagine dell'antico galateo. Il lato del diavolo dunque (quello dietro al quale ancora oggi getta il sale versato), altro non era che il versante dell'igiene intima, implicato nel contatto impuro con la sessualità e la sporcizia delle pudenda. Era altresì proibito guardare negli occhi o nel piatto un commensale più anziano o di casta superiore, e nel caso di un re o di un principe, era assolutamente vietato anche solo presenziare al suo pasto o al suo semplice abbeverarsi; questo per due motivi: da un lato perché il mangiare e il bere sono gesti ritenuti vili e troppo umani, che hanno a che fare con gli appetiti quotidiani, che rischiano di ridurre l'origine "divina" dei regnanti, inoltre, come accade nel regno animale (ad esempio i cani, che non possono guardare il capo-branco mentre mangia), questo serviva a evidenziare le gerarchie a tavola.
Acqua
Nell'antichità era usata, gelata o bollente, nel rito della "ordalia", in cui un tribunale speciale emetteva un giudizio di innocenza o di colpevolezza basandosi sul fatto (assai poco giuridico), che il condannato sopravvivesse o meno ad un'immersione (prolungata) in una vasca d'acqua bollente oppure ghiacciata.
Cipolla
- Una famosissima superstizione vuole protegga dai demoni e che favorisca la guarigione dei malati, se posta fuori dalla finestra di casa e tagliata in due parti uguali.
- La crommiomanzia consiste in un oracolo d'amore ancora in uso in certe campagne del nord Italia, secondo cui se una ragazza incide il nome dell'uomo amato su una cipolla, e se questa poi germoglia, significa che anche lui ricambia l'amore.
- Se si vuole conoscere in anticipo il clima dell'anno nuovo, il giorno del 24 gennaio bisogna mettere 12 spicchi di cipolla con sopra del sale fuori dalla finestra, uno di seguito all'altro. Ognuno rappresenta un mese dell'anno entrante, e dal loro aspetto e colore, da come assorbono il sale, ecc, si dice che si possa comprendere il meteo dei rispettivi mesi.
Digiuno
In Cina i magistrati digiunavano prima di emettere la sentenza di un processo per vedere in sogno il colpevole.
Latte
- Da sempre considerato un alimento benedetto e protettivo, nei testi biblici la terra promessa (ma anche il Paradiso) è presentato come fiume di latte, simbolo ovviamente di un ritrovato rapporto con la madre. Anche la via lattea degli astronomi, vuole un'antica leggenda greca, che debba derivare in realtà da uno spruzzo di latte della dea greca Giunone.
- Siccome si crede che annulli ogni magia negativa, una superstizione vuole che si debba lasciare un bicchiere di latte in casa, anche di notte.
Mandorla/nocciola
Essendo il simbolo della rinascita e della primavera (l'albero di mandorla è il primo a fiorire in primavera), una superstizione vuole che se una fanciulla si addormentata sotto mandorlo, resterà in cinta.
Pane
- la superstizione che vuole che porti male buttare via il pane, trova origine nella preghiera del Padre Nostro, per cui sarebbe offensivo verso Dio gettare (e quindi rifiutare) il "pane quotidiano" che Lui ci dona.
- la superstizione invece secondo cui il pane non deve mai essere rovesciato (messo a testa in giù) ha un'origine molto complessa: nel medioevo, la paura collettiva della morte aveva creato la proibizione assoluta di toccare qualsiasi cosa che avesse avuto a che fare con i cadaveri. Si trattava anche di una tutela igienico-sanitaria. Per questo motivo gli oggetti e cibi destinati al boia non dovevano entrare in contatto con quelli altrui. I loro abiti venivano lavati a parte ed anche i loro cibi venivano preparati a parte. In materia di pane, i fornai avevano inventato un sistema facile per rendere riconoscibile il pane destinato al boia, così che anche nel forno di cottura, non entrasse in contatto con quello altrui. Questo sistema consisteva nel girare il pane a testa in giù, rovesciandolo. Per questo veniva chiamato il "pane del boia", ed ancora oggi il pane rovesciato si porta dietro questo triste presagio di morte.
Sale
- E' notoriamente considerato di cattivo auspicio il fatto di versarlo a tavola perché si crede che lo fece Giuda prima di tradire Gesù, durante l'ultima cena. Anche molti pittori, tra cui Leonardo da Vinci nel Cenacolo, ritraggono infatti il personaggio di Giuda intento a baciare Gesù mentre fa cadere con un gomito un contenitore di sale sulla tavola.
- Se però il sale è già caduto, un'altra superstizione prevede che si possa annullare il suo effetto malefico gettandolo dietro la spalla sinistra (quella del diavolo), per accecare il diavolo.
- un'altra superstizione consiglia di portarlo in tasca per protezione dai pericoli, o meglio ancora, di lavarci i vestiti.
Uovo
Una superstizione vuole che se contiene 2 tuorli annuncia un decesso.
Enzo Bianchi
Non so amare dunque mangio.
La Stampa, 25 novembre 2007
Oggi abbiamo una conoscenza umana, medica e spirituale che pare consentirci di reagire con maggior consapevolezza ed efficacia a quelle “malattie dello spirito” che dai primi secoli del cristianesimo vengono chiamate “vizi capitali”, ma una lettura attenta del messaggio che si cela nel classico elenco delle otto passioni, lo rivela ancora estremamente istruttivo e attuale. Questi “pensieri” che assillano l’essere umano esprimono patologie nei rapporti che l’uomo intrattiene con le dimensioni essenziali della sua vita umana e spirituale: così la gola o ingordigia riguarda il rapporto con il cibo, la lussuria quello con il corpo e la sessualità, l’avarizia il rapporto con le cose, la collera concerne il rapporto con gli altri, la tristezza e l’acedia quelli con il tempo e lo spazio, la vanagloria tocca il rapporto con il fare e, infine, l’orgoglio riguarda il rapporto con Dio. E’ l’essere umano nella sua interezza che è in gioco, proprio nella qualità dei rapporti con la realtà a lui esterna, nei diversi ambiti della sua esistenza.
Ora, perché la passione designata con il termine gastrimarghía, “follia del ventre” e conosciuta dalla tradizione occidentale come “gola”, è la prima della lista? Il racconto biblico di Adamo ed Eva conferma quanto ci dice la nostra esperienza, cioè che ogni vizio umano si innesta sul livello del bisogno primario per eccellenza, quello del nutrimento: occorre mangiare per vivere. Ma l’ingordigia non indica né il naturale soddisfacimento di questo bisogno, né il piacere nel mangiare o il gusto per la bontà dei cibi; no, l’ingordigia è un atteggiamento di smoderatezza in rapporto al cibo, una “brama di cibo non ordinata” che si articola poi in golosità, cioè eccesso nella ricerca della qualità del cibo, e in voracità, incapacità a rispettare tempi e modi nel mangiare. Sì, mangiare è una funzione essenziale, ma rischia sempre di ridursi a un’animalità irriflessa, non ragionata. Ora, se è vero che noi oggi diamo poca importanza alla voracità, lo è altrettanto il dato che, mai come oggi, sperimentiamo quanto essa sia dannosa per la nostra salute. È paradossale eppure reale: siamo disposti ad accettare i disagi provenienti dagli abusi nel nostro rapporto con il cibo più che non quelli causati da un suo retto uso, cioè le moderate rinunce e la sobrietà che ci consentirebbero di intrattenere un sano rapporto con il nostro corpo. Come non ricordare che la nostra società, mal disposta verso queste “lotte spirituali”, in realtà reintroduce quasi le stesse discipline raccomandate dalla tradizione cristiana – cioè esercizi, digiuni, diete –, per ragioni dietetiche ed estetiche? Nel contesto culturale della nostra “società dei consumi”, dove il cibo non manca mai, l’ingordigia si declina proprio come un vizio di consumo: si tende a ingurgitare cibo alla stregua di carburante per il funzionamento della nostra macchina-corpo, e questa patologia del nutrimento è banalmente giustificata con la mancanza di tempo e l’esigenza di produrre. Non a caso questo imbarbarimento nei rapporti con il cibo ha investito anche l’ambito della preparazione degli alimenti e della sua assunzione: sono scomparse le dimensioni quasi rituali del far da mangiare, cioè del curare la trasfigurazione del cibo da crudo a cotto, e dello “stare” a tavola: oggi si cucina il meno possibile, si mangia velocemente, in piedi, con le mani, guardando la televisione... E questo nonostante ci rendiamo conto noi stessi di come l’ingordigia ci renda pesanti in senso proprio e figurato: subito dopo un pasto smodato siamo presi da intontimento, da un torpore che offusca l’intelligenza e la lucidità; oppure, e sovente le due cose vanno insieme, avvertiamo sfrenatezza, eccitazione, perdita dei freni inibitori alla lingua, ai gesti, allo stare in mezzo agli altri...
Qui possiamo cogliere meglio l’intuizione patristica dell’ingordigia quale “porta di tutte le passioni”, una porta che si spalanca proprio in quel luogo che è manifestazione del nostro rapporto con il cibo, la tavola: luogo destinato alla condivisione, allo scambio della parola, all’effusione dell’affetto, eccolo trasformato, da un eccesso di cibo e bevande, in focolaio di liti e di violenze, sfogo di ogni aggressività.
Ma sappiamo bene che l’atto del mangiare non ha a che fare solo con il nutrimento fisico, ma appartiene al registro del desiderio e riveste importanti connotazioni affettive e simboliche: il mangiare è atto primordiale e riconoscimento iniziale del mondo; è un rinvio all’attività culturale dell’uomo; è la possibilità di dire che si ama e che si accetta di essere amati. Lo testimonia l’esperienza originaria del neonato, che lo porta a relazionarsi al mondo esterno succhiando il latte, cibandosi cioè della sua stessa madre. Il neonato cerca il seno materno con desiderio prepotente e quasi insaziabile, fino a non distinguere tra la matrice e la persona della madre: vorrebbe divorare questa matrice, avere tutta per sé questa fonte e termine di ogni suo desiderio e bisogno. E noi oggi siamo consapevoli che esperienze traumatiche vissute dal bambino nelle sue relazioni con la madre, soprattutto nella fase dell’allattamento e dello svezzamento, rischiano di causare fissazioni o regressioni a comportamenti infantili, allo “stadio orale”.
Ora, proprio quelle frustrazioni orali che segnano in profondità il nostro inconscio possono generare fami divoranti o altrettanto divoranti astensioni dal cibo. È nel rapporto con il cibo, infatti, che si cercano soluzioni al proprio malessere, con conseguenze mortifere: bisogno di ingurgitare grandi quanti quantità di cibo o di bevande, fino alla bulimia, per soddisfare un’irrefrenabile pulsione orale; oppure, al contrario, rifiuto di ingerire il nutrimento necessario, fino all’anoressia. Prima di essere indice di un malessere spirituale, l’ingordigia si manifesta pertanto come una furiosa perversione del desiderio, che può assumere il volto della psicosi e della nevrosi: che cosa sono infatti bulimia e anoressia se non indici di turbamenti affettivi che si ripercuotono sull’alimentazione?
E così il cibo finisce per sostituirsi all’amore, e il rapporto con esso diventa un mezzo per occultare la sofferenza: l’amore è irraggiungibile, mentre il cibo è a portata di mano… Nella voracità avviene lo stravolgimento del mezzo in fine: il cibo non è più inteso come uno strumento per vivere, per condividere e per festeggiare, ma come una sorta di fine in se stesso! Ecco perché il percorso di crescita umana e spirituale richiede necessariamente la capacità di ordinare tutti i nostri appetiti, a partire da quello fondamentale del cibo. Lì si decide la nostra libertà, lì è il terreno privilegiato per conoscere da cosa siamo abitati.
ODISSEA
Indice
- Odissea
- U. Foscolo: A Zacinto
- G. D'Annunzio: Maia IV
- G. Pascoli: L'ultimo viaggio di Ulisse
- K. Kavafis: Itaca
- G. Ungaretti: Allegria di naufragi
- G. Gozzano: Ulisse naufraga...a bordo di uno yacht
- U. Saba: Ulisse
- P. Levi: Il canto di Ulisse
- F. Guccini: Odysseus
- L. Dalla: Itaca
(VIII sec. a.C.)
Proemio
Narrami, o Musa , dell’eroe multiforme, che tanto
vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia:
di molti uomini vide la città e conobbe i pensieri,
molti dolori patì sul mare nell’animo suo,
per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni.
Ma i compagni neanche così li salvò, pur volendo:
con la loro empietà si perdettero,
stolti, che mangiarono i buoi del Sole
Imperione: ad essi egli tolse il dì del ritorno.
Racconta qualcosa anche a noi, o dea figlia di Zeus.
Ugo Foscolo
A Zacinto (1803)
Né più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell'onde
del greco mar da cui vergine nacque
Venere, e fea quelle isole feconde
col suo primo sorriso, onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue fronde
l'inclito verso di colui che l'acque
cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai del figlio,
o materna mia terra; a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura.
Gabriele D’Annunzio
Maia IV (1903)
E incontrammo un Eroe.
Incontrammo colui
che i Latini chiamano Ulisse,
nelle acque di Leucade, sotto
le rogge e bianche rupi
che incombono al gorgo vorace,
presso l'isola macra
come corpo di rudi
ossa incrollabili estrutto
e sol d'argentea cintura
precinto. Lui vedemmo
su la nave incavata. E reggeva
ei nel pugno la scotta
spiando i volubili vènti,
silenzioso; e il pìleo
tèstile dei marinai
coprivagli il capo canuto,
la tunica breve il ginocchio
ferreo, la palpebra alquanto
l'occhio aguzzo; e vigile in ogni
muscolo era l'infaticata
possa del magnanimo cuore.
E non i tripodi massicci,
non i lebeti rotondi
sotto i banchi del legno
luceano, i bei doni
d'Alcinoo re dei Feaci,
né la veste né il manto
distesi ove colcarsi
e dormir potesse l'Eroe;
ma solo ei tolto s'avea l'arco
dell'allegra vendetta, l'arco
di vaste corna e di nervo
duro che teso stridette
come la rondine nunzia
del dì, quando ei scelse il quadrello
a fieder la strozza del proco.
Sol con quell'arco e con la nera
sua nave, lungi dalla casa
d'alto colmigno sonora
d'industri telai, proseguiva
il suo necessario travaglio
contra l'implacabile Mare.
Giovanni Pascoli
L’ultimo viaggio di Ulisse (1905)
[...]
E la corrente tacita e soave
Più sempre avanti sospingea la nave.
E il vecchio vide che le due Sirene,
le ciglia alzate sulle due pupille,
avanti se miravano, nel sole
fisse, od in lui, nella sua nave nera.
E su la calma immobile del mare,
alta e sicura egli inalzò la voce.
"Son io! Son io, che torno per sapere!
Che molto io vidi, come voi vedete
Me. Sì; ma tutto ch'io guardai nel mondo,
mi riguardò; mi domandò: Chi sono?"
e la corrente rapida e soave
più sempre avanti sospingea la nave.
E il vecchio vide un gran mucchio d'ossa
D'uomini, e pelli raggrinzate intorno,
presso le due Sirene, immobilmente
stese sul lido, simili a due scogli.
"Vedo. Sia pure. Questo duro ossame
cresca quel mucchio. Ma, voi due, parlate!
Ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto,
prima ch'io muoia, a ciò ch'io sia vissuto!"
E la corrente rapida e soave
Più sempre avanti sospingea la nave.
E s'ergean su la nave alte le fronti,
con gli occhi fissi, delle due Sirene.
"Solo mi resta un'attimo. Vi prego
!
Ditemi almeno chi sono io! Chi ero!"
E tra i due scogli si spezzò la nave.
[....]
Konstantinos Kavafis
(Cinquantacinque poesie, 1911)
Itaca
Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere d'incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo
nè nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d'estate siano tanti
quando nei porti - finalmente, e con che gioia -
toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi
penetranti d'ogni sorta, più profumi
inebrianti che puoi,
va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
Sempre devi avere in mente Itaca -
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos'altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
Giuseppe Ungaretti
Allegria di naufragi
E subito riprende
il viaggio
come
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare.
(Versa il 14 febbraio 1917)
Guido Gozzano
Ulisse naufraga … a bordo d’un yacht (1910)
Il Re di Tempeste era un tale
che diede col vivere scempio
un bel deplorevole esempio
d’infedeltà maritale,
che visse a bordo d’un yacht
toccando tra liete brigate
le spiagge più frequentate
dalle famose cocottes.
Già vecchio, rivolte le vele
al tetto un giorno lasciato,
fu accolto e fu perdonato
dalla consorte fedele...
Poteva trascorrere i suoi
ultimi giorni sereni,
contento degli ultimi beni
come si vive tra noi...
Ma né dolcezza di figlio,
né lagrime, né la pietà
del padre, né il debito amore
per la sua dolce metà
gli spensero dentro l’ardore
della speranza chimerica
e volse coi tardi compagni
cercando fortuna in America...
-Non si può vivere senza
danari, molti danari...
Considerate, miei cari
compagni, la vostra semenza!-
Viaggia viaggia viaggia
viaggia nel folle volo:
vedevano già scintillare
le stelle dell’altro polo...
Viaggia viaggia viaggia
viaggia per l’alto mare:
si videro innanzi levare
un’alta montagna selvaggia...
Non era quel porto illusorio
la California o il Perù,
ma il monte del Purgatorio
che trasse la nave all’in giù.
E il mare sovra la prora
si fu richiuso in eterno.
E Ulisse piombò nell’Inferno
dove ci resta tuttora...
Umberto Saba
Ulisse (1946)
Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.
Primo Levi
Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo 1956)
Primo Levi si sforza di richiamare alla memoria il viaggio di Ulisse raccontato nel XXVI dell’Inferno, per insegnare l’italiano ad un compagno di prigionia di nome Jean, soprannominato Pikolo.
Quelle parole, faticosamente rivissute, si
traducono nella rappresentazione universale del destino di «tutti gli uomini in travaglio».
[…]
Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente: ma non abbiamo tempo di scegliere, quest’ora già non è più
un’ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà: oggi mi sento da tanto.
[…]
Chi è Dante. Che cosa è la Commedia. Quale sensazione curiosa di novità si prova, se si cerca di spiegare in breve che cosa è la Divina Commedia. Come è distribuito l’Inferno, cosa è il contrappasso . Virgilio è la Ragione, Beatrice la Teologia. Jean è attentissimo, ed io comincio, lento e accurato:
Lo maggior corno della fiamma antica
cominciò a crollarsi mormorando,
pur come quella cui vento affatica.
Indi, la cima in qua e in là menando
come fosse la lingua che parlasse
mise fuori la voce, e disse: Quando…
Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso: povero Dante e povero francese! Tuttavia l’esperienza pare che prometta bene: Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua , e mi suggerisce il termine appropriato per rendere “antica”.
E dopo “Quando”? Il nulla, Un buco della memoria. “Prima che sì Enea la nominasse ”. Altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile: “…la piéta Del vecchio padre, né’l debito amore Che doveva Penelope far lieta…” sarà poi esatto?
…Ma misi me per l’alto mare aperto.
Di questo sì, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere perché “misi me” non è “je me mis”, è molto più forte e più audace, è un vincolo infranto, è scagliare se stessi al di là della barriera, noi conosciamo bene questo impulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è quando l’orizzonte si chiude su se stesso, libero diritto e semplice, e non c’è ormai che odore di mare: dolci cose ferocemente lontane.
Siamo arrivati a Kraftwerk , dove lavora il Kommando dei posacavi. Ci dev’essere l’ingegner Levi . Eccolo, si vede solo la testa fuori dalla trincea. Mi fa un cenno con la mano, è un uomo in gamba, non l’ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare.
«Mare aperto». «Mare aperto». So che rima con «diserto»: «…quella compagna Picciola, dalla qual non fui diserto», ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d’Ercole, che tristezza, sono costretto a raccontarlo in prosa: un sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi:
…Acciò che l’uom più oltre non si metta.
“Si metta”: dovevo venire in Lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, “ e misi me”. Ma non ne faccio
parte a Jean, non sono sicuro che sia un’osservazione importante. Quante altre cose ci sarebbero da dire, e il sole è già alto,
mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda.
Ecco, attento Pikolo, apri gli occhi e la mente, ho bisogno che tu capisca:
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.
Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.
Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo bene. O forse è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio , e noi in specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle.
Li miei compagni fec’io sì acuti…
…e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo “acuti”. Qui ancora una lacuna, questa volta irreparabile. “…Lo lume era di sotto della luna” o qualcosa di simile; ma prima?… Nessuna idea, “keine Ahnung” come si dice qui. Che Pikolo mi scusi, ho dimenticato almeno quattro terzine.- Ça ne fait rien, vas-y tout de même.
…Quando mi apparve una montagna, bruna
per la distanza, e parvemi alta tanto
che mai veduta non ne avevo alcuna.
Sì, sì, «alta tanto», non «molto alta», proposizione consecutiva. E le montagne, quando si vedono di lontano…le montagne…oh Pikolo, Pikolo, di’ qualcosa, parla, non lasciarmi pensare alle mie montagne, che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino!
Basta, bisogna proseguire, queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Pikolo attende e mi guarda.
Darei la zuppa di oggi per sapere saldare “non ne avevo alcuna” col finale. Mi sforzo di ricostruire per mezzo delle rime,
chiudo gli occhi, mi mordo le dita: ma non serve, il resto è silenzio. Mi danno per il capo altri versi: “…la terra
lagrimosa diede vento…” no, è un’altra cosa. E’ tradi, è tradi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere:
Tre volte il fe’ girar con tutte l’acque,
alla quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, come altrui piacque…
Trattengo Pikolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo «come altrui piacque», prima che sia troppo tardi, domani lui o io possiamo essere morti, o non vederci mai più, devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario e pure inaspettato anacronismo , e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino , del nostro essere oggi qui…
Siamo oramai nella fil per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta-zuppa degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. –Kraut und Ruben? - Kraut und Ruben. Si annuncia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape: -Choux et navets .- Kaposzta es repark .
Infin che’l mar fu sopra noi rinchiuso.
Francesco Guccini
Odysseus (2004)
Bisogna che lo affermi fortemente
che, certo, non appartenevo al mare
anche se Dei d'Olimpo e umana gente
mi sospinsero un giorno a navigare,
e se guardavo l'isola petrosa,
sopra ogni collina c'erano lì idealmente
il mio cuore al sommo d'ogni cosa,
c'era l'anima mia che è contadina
un'isola d'aratro e di frumento
senza le vele senza pescatori
il sudore e la terra erano argento
il vino e l'olio erano i miei ori
Ma se tu guardi un monte che è di faccia,
senti che ti sospinge un altro monte
un'isola col mare che l'abbraccia
ti chiama un'altra isola di fronte
e diedi un volto a quelle mie chimere
le navi costruii di forma ardita,
concavi navi dalle vele nere
e nel mare cambiò quella mia vita
e il mare trascurato mi travolse:
seppi che il mio futuro era sul mare
con un dubbio però che non si sciolse
senza futuro era il mio navigare
Ma nel futuro trame di passato
si uniscono a brandelli di presente,
ti esalta l'acqua e al gusto del salato
brucia la mente
e ad ogni viaggio reinventarsi un mito
a ogni incontro ridisegnare il mondo
e perdersi nel gusto del proibito
sempre più in fondo
E andare in giorni bianchi come arsura,
soffio di vento e forza delle braccia,
mano al timone e sguardo nella pura
schiuma che lascia effimera una traccia;
andare nella notte che ti avvolge
scrutando delle stelle il tremolare
in alto l'Orsa e un segno che ti volge
diritta verso il nord della Polare.
E andare come spinto dal destino
verso una guerra, verso l'avventura
e tornare contro ogni vaticino
contro gli Dei e contro la paura.
E andare verso isole incantate,
verso altri amori, verso forze arcane,
compagni persi e navi naufragate;
per mesi, anni, o soltanto settimane
La memoria confonde e dà l'oblio,
chi era Nausicaa, e dove le sirene
Circe e Calypso perse nel brusio
di voci che non so legare assieme.
Mi sfuggono il timone, velam remo,
la frattura fra inizio ed il finire,
l'urlo dell'accecato Polifemo
ed il mio navigare per fuggire.
E fuggendo si muore e la mia morte
sento vicina quando tutto tace
sul mare, e maledico la mia sorte
non trovo pace
forse perché sono rimasto solo
ma allora non tremava la mia mano
e i remi mutai in ali al folle volo
oltre l'umano.
La vita del mare segna false rotte,
ingannevole in mare ogni tracciato,
solo leggende perse nella notte
perenne di chi un giorno mi ha cantato
donandomi però un'eterna vita
racchiusa in versi, in ritmi, in una rima,
dandomi ancora la gioia infinita
di entrare in porti sconosciuti prima"
Lucio Dalla
Itaca (2006)
Capitano che hai negli occhi
il tuo nobile destino
pensi mai al marinaio
a cui manca pane e vino
capitano che hai trovato
principesse in ogni porto
pensi mai al rematore
che sua moglie crede morto
itaca, itaca, itaca
la mia casa ce l'ho solo la'
itaca, itaca, itaca
ed a casa io voglio tornare
dal mare, dal mare, dal mare
capitano le tue colpe
pago anch'io coi giorni miei
mentre il mio piu' gran peccato
fa sorridere gli dei
e se muori e' un re che muore
la tua casa avra' un erede
quando io non torno a casa
entran dentro fame e sete
itaca, itaca, itaca
la mia casa ce l'ho solo la'
itaca, itaca, itaca
ed a casa io voglio tornare
dal mare, dal mare, dal mare
capitano che risolvi
con l'astuzia ogni avventura
ti ricordi di un soldato
che ogni volta ha piu' paura
ma anche la paura in fondo
mi da' sempre un gusto strano
se ci fosse ancora mondo
sono pronto dove andiamo
itaca, itaca, itaca
la mia casa ce l'ho solo la'
itaca, itaca, itaca
ed a casa io voglio tornare
dal mare, dal mare, dal mare
itaca itaca itaca
la mia casa ce l'ho solo la'
itaca, itaca, itaca
ed a casa io voglio tornare...
SERVIZI SPAZIOPREVER
HOMEPAGE
Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
 Dante Alighieri
Dante Alighieri
